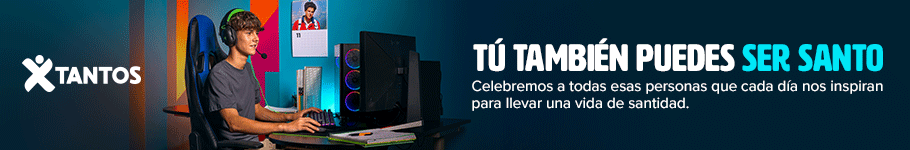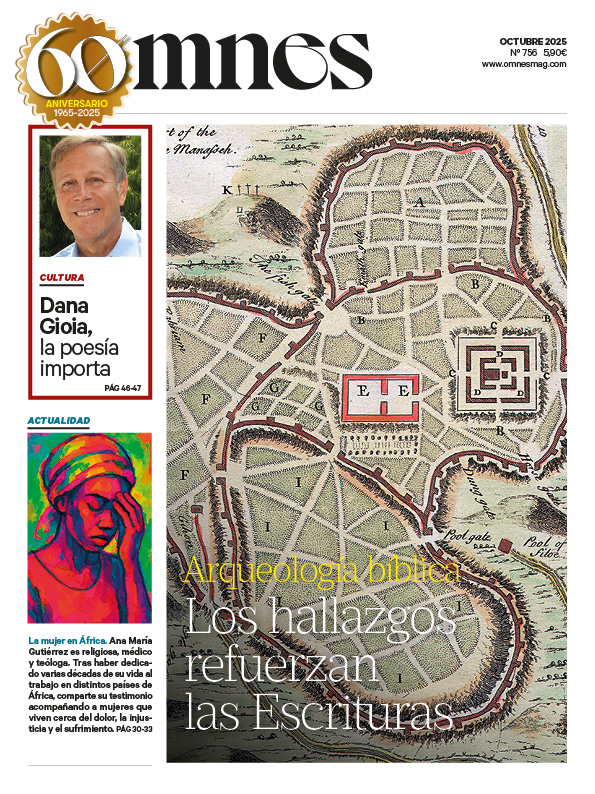Bastava guardare i media del Vaticano II per sapere che una delle personalità che dedicò il meglio dei suoi sforzi alla stesura dei documenti dell'Assemblea Magna fu don Alvaro del Portillo, segretario della Commissione conciliare incaricata di preparare il Decreto «De Presbyteris».
Giovanni XXIII aveva nominato il dottor Del Portillo presidente della Commissione Antepreparatoria sui Laici e, successivamente, segretario della Commissione Conciliare sulla Disciplina del Clero, incaricato, come ho già detto, dello schema «De presbyterorum ministerio et vita». Entrambe le cariche sono emblematiche della vita di questo illustre sacerdote spagnolo. Don Álvaro del Portillo ha conseguito un dottorato in Filosofia e Lettere e un dottorato in Ingegneria civile. Membro dell'Opus Dei fin dagli inizi dell'Associazione, ha lavorato intensamente come ingegnere. Ordinato sacerdote nel 1944, ha conseguito il dottorato in Diritto canonico e ha sempre svolto un servizio responsabile alla Chiesa, con impegno e fedeltà esemplari. Vive a Roma ed è Segretario generale dell'Opus Dei.
È più o meno l'uomo che cercavo per spiegare ai lettori di PALABRA la figura del sacerdote che stava delineando il Concilio. Pochi punti di maggiore interesse - e da parte di una persona così autorevole - potevano infatti essere fatti in una rivista sacerdotale. L'enorme compito che gravava sulla Commissione Da Presbyteris - lavorava giorno e notte - ha reso praticamente impossibile avvicinare don Álvaro. Gli inviai un questionario. Il Consiglio era finito. Tre giorni dopo avevo le risposte in mio possesso.
-Come ben sapete, il voto finale sul Decreto «Presbyterorum Ordinis» e la sua promulgazione da parte del Santo Padre avvennero il 7 dicembre, alla vigilia della solenne chiusura del Concilio Ecumenico. Se prima di quelle date non volli accettare l'intervista, fu per ragioni facilmente comprensibili, che si possono ridurre a una: essendo il segretario della stessa Commissione conciliare che preparò il Decreto, non mi sembrava delicato dare pubblicamente il mio parere su problemi che erano ancora in fase di studio. E tanto meno nel caso di un problema - il ministero e la vita dei sacerdoti - su cui la letteratura recente ha posto tanta appassionata enfasi polemica....
-«L'Osservatore Romano», riprendendo l'opinione dei Padri conciliari, ha definito il Decreto «Presbyterorum Ordinis» come uno dei migliori e più completi documenti del Concilio Vaticano II. Ritiene che questo insegnamento del Concilio possa sanare la controversia a cui ha accennato prima?
-Io penso di sì. E non solo per la forza morale della sua autorità, trattandosi di un documento del Magistero solenne, ma anche per la stessa struttura dottrinale del suo contenuto. Le diverse concezioni e opinioni particolari sui modi in cui si deve manifestare oggi la vita e il compito apostolico dei sacerdoti possono essere facilmente conciliate solo ponendo il problema su un piano non esclusivamente disciplinare, né solo pastorale, né solo morale o ascetico. Proprio l'unilateralità dei punti di vista ha portato alla diversità delle conclusioni, talvolta fortemente e polemicamente opposte tra loro. Il Concilio Ecumenico, invece, ha considerato e studiato il problema in modo globale, partendo dalla teologia del sacerdozio per poi scendere progressivamente alle comuni conseguenze pastorali, ascetiche e disciplinari che la particolare consacrazione e la specifica missione ricevuta hanno sul ministero e sulla vita dei sacerdoti.
-È la prima volta nella storia della Chiesa che un documento conciliare si occupa in modo specifico del presbiterato. Quali sono state le ragioni?
-Di fronte al notevole sviluppo della dottrina sull'episcopato e sul sacerdozio comune dei fedeli, molti sacerdoti si interrogavano giustamente sull'esatto valore e significato del loro sacerdozio, del loro compito apostolico all'interno dell'unica missione della Chiesa. D'altra parte, in un mondo in continua evoluzione sociale e culturale, era necessario chiarire i termini fondamentali della necessaria sistemazione del ministero e della vita sacerdotale. Ma soprattutto, come si può pensare a un rinnovamento missionario della Chiesa senza che la santità di vita e la sollecitudine pastorale dei suoi sacerdoti ne costituiscano il fondamento principale?
-Quali sono, secondo lei, le caratteristiche principali che delineano la figura teologica del presbitero?
-Consacrazione e missione. La duplice realtà significata nel noto passo della Lettera agli Ebrei, quinto capitolo, primo versetto, dove si dice che il sacerdote «ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur”. Scelto tra i membri del popolo sacerdotale di Dio, il sacerdote partecipa, con una nuova e speciale consacrazione, al sacerdozio ministeriale di Cristo stesso. Non è concepibile una maggiore elevazione della creatura, né una maggiore intimità con Dio nella sua opera di redenzione. La debolezza umana viene assunta, non solo per cooperare con Cristo, ma per rappresentarlo davanti agli uomini, per agire nel suo stesso nome e nella sua persona. Infatti, come conseguenza di questa partecipazione al sacerdozio ministeriale di Cristo, il sacerdote è assegnato alla missione di evangelizzare, santificare e governare, in comunione gerarchica con i vescovi, il popolo di Dio. In ciò è racchiusa tutta la misteriosa grandezza della vita sacerdotale: una consacrazione speciale (che si aggiunge a quella battesimale) che separa l'uomo dagli altri uomini, e una missione che destina questo stesso uomo al servizio pastorale dei suoi fratelli. Due dimensioni - una verticale, di adorazione; l'altra orizzontale, di servizio - della stessa vita, insieme consacrata e inviata; una vita «in dialogo» allo stesso tempo con Dio e con gli uomini.
-Nel mondo di oggi, date le nuove circostanze sociali e culturali a cui ha fatto riferimento prima, come devono orientare i sacerdoti questo dialogo con il mondo e con le persone? Quali caratteristiche fondamentali deve avere il compito missionario e pastorale dei sacerdoti - vescovi e sacerdoti - perché sia veramente un ministero, un servizio?
-Penso che le forme concrete varieranno con i diversi ambienti e livelli culturali. Ma in ogni caso, è chiaro che l'uomo della strada - dell'università, dell'ufficio, della campagna - è disposto ad ascoltare solo il sacerdote, il «prete», che sa rivolgersi a lui con una semplicità di trattamento umano (come uomo, direi, «a portata di mano») e allo stesso tempo con un sincero e profondo senso soprannaturale (come uomo di Dio). Semplicità di trattamento umano - il eximia humanitas necessario per il conversatio cum hominibuCome si legge nel Decreto - significa, innanzitutto, l'esercizio di una serie di qualità o virtù naturali fondamentali (sincerità, lealtà, amore per la giustizia, fierezza, capacità di comprensione, rispetto per la giusta libertà e autonomia dei laici nelle questioni temporali, ecc.) Poi, significa anche la capacità di stimare e valorizzare adeguatamente tutte le nobili realtà umane: il lavoro professionale (come Cristo a Nazareth), l'amore umano (come Cristo a Cana o a Naim), l'amicizia (come Cristo a Betania), e così via. È così che le persone scoprono nel sacerdote la disponibilità e la comprensione che facilita il dialogo e, con il dialogo, l'insegnamento. È così che si arriva a considerare il sacerdote come una figura vicina, familiare e amichevole, e non come un essere distante, singolare e strano.
-Vale a dire che a noi ecclesiastici è richiesto di essere - scusate l'espressione - meno impiegatizio che in altri momenti, una minore impiegatizio Come dobbiamo comportarci nella società civile e nei rapporti con i laici?
-Se inserite il vostro articolo impiegatizio in corsivo, rispondo di sì. Meno clericale e più sacerdotale. Perché quei modi e quella mentalità clericale a cui lei si riferisce - frequenti in non pochi chierici del passato - erano frutto di un falso concetto di potere (che poneva l'accento più sulla coercizione che sull'autorità morale) e di un falso «soprannaturalismo», poco soprannaturale. Penso che molte delle persone che si sono dichiarate o si dichiarano «anticlericali», come spesso si dice, lo abbiano fatto per reazione a quei modi e a quella mentalità, che certamente non ha nulla a che fare - come l'esempio di tanti altri magnifici sacerdoti non ha mai smesso di testimoniare - con un'anima sinceramente sacerdotale, né con le vere esigenze del ministero pastorale. Ma si vede che è un problema di «mentalità», di contesto interiore e, quindi, di formazione intellettuale, di approfondimento dottrinale e ascetico. In altre parole, è qualcosa che non può essere affrontato con soluzioni superficiali ed esteriori, che, oltre a essere semplicistiche, sarebbero purtroppo controproducenti. Ad esempio, l'abolizione dell'abito sacerdotale (talare, clergyman o saio), l'ammirazione indiscriminata e sciocca per tutto ciò che è «laico», la «temporalizzazione» del ministero sacerdotale, riducendolo ai soli compiti di assistenza sociale o economica, e così via.
È proprio per questo motivo che il Decreto. «Presbyterorum Ordinis» insiste sul fatto che l'esaltata humanitas del sacerdote deve sempre essere strettamente accompagnata da un profondo senso soprannaturale delle realtà terrene, della propria condizione sacerdotale e del proprio dovere di stato. Nulla, infatti, renderebbe più difficile il dialogo con gli uomini del nostro tempo di una sorta di atteggiamento «naturalistico» da parte del sacerdote.
-Per quali ragioni esattamente?
-Perché - e questo è uno dei grandi valori morali e culturali del nostro tempo - la gente oggi ama appassionatamente l'autenticità degli atteggiamenti, la sincerità delle persone, e rifiuta automaticamente tutto ciò che sa di falsità, di finzione, di falso o di mancanza di responsabilità: e un atteggiamento «naturalistico» nel sacerdote sarebbe tutte queste cose allo stesso tempo. Ma, soprattutto, perché ciò che la gente vuole, ciò che si aspetta - anche se spesso non sa o non si rende conto di volerlo e di aspettarselo - è che il sacerdote, con la sua testimonianza di vita e con la sua parola, parli loro di Dio. E se il sacerdote non lo fa, se non li cerca per questo, se non li aiuta ad ascoltare, a scoprire o a capire la dimensione religiosa della loro vita, allora il sacerdote li delude, proprio come li deluderebbe un pompiere senza acqua, un taverniere - perdonate la similitudine - che dispensa latte, o un medico che non osa diagnosticare e prescrivere. Oggi le persone chiedono certamente che si parli loro in modo molto specifico - positivo, vitale, aderente ai loro concreti problemi spirituali e umani, incoraggiante e pieno di quell'ottimismo cristiano chiamato «spirito pasquale» - ma vogliono e si aspettano che si parli loro di Dio, e che si parli loro apertamente, perché ci sono già troppe cose nella loro vita sociale che lo nascondono. Si rendono conto di avere bisogno di Dio. Anche la persona più esigente nella fretta delle sue mille occupazioni quotidiane, anche la più distante o quella che sembra più indifferente: tutti, in un modo o nell'altro, con maggiore o minore consapevolezza o lucidità, portano sulle spalle questo problema esistenziale di Dio. E il sacerdote -homo fidei, ministro dell'Evangelii, educatore in fide- ha questo come primo dovere del suo ministero: risvegliare quella luce o ravvivarla, portarla al livello della coscienza personale.
In breve, una sincera umanità nella forma e un profondo spirito soprannaturale nel contenuto. Lo stesso Decreto conciliare insegna che l'Eucaristia è la fonte e il culmine del ministero sacerdotale. E nell'Eucaristia Cristo manifesta in modo eclatante, allo stesso tempo, l'ineffabile vicinanza all'uomo del Figlio dell'uomo e l'infinito amore salvifico del Figlio di Dio.
Ci rendiamo conto - pensando al presbiterato, alla riaffermazione del celibato ecclesiastico, alla riforma dell'incardinazione e dei benefici, e così via - che abbiamo avuto appena il tempo di abbozzare alcune delle tante domande che avremmo voluto porre a don Alvaro del Portillo, uno degli esperti che più hanno contribuito al laborioso lavoro del Concilio.
Ci sono - come si suol dire - molte altre questioni lasciate in sospeso. Chissà se la gentilezza di don Álvaro non ci permetterà di riprendere questo dialogo in un secondo momento?
Sacerdote, laureato in giornalismo all'Università di Navarra e dottore in diritto canonico.