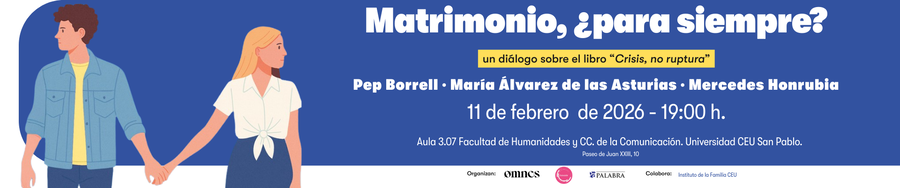Il 26 maggio è la festa di San Filippo Neri, compatrono di Roma e santo a cui il cristianesimo deve molto.
La vita
Fiorentino di nascita (nacque nel 1515), si trasferì a Roma all'età di diciannove anni e non la lasciò più, conducendo per una decina d'anni un'austera vita laica di intensa preghiera (che alternò al lavoro di precettore di bambini). Trascorse intere notti a vegliare nelle catacombe di San Sebastiano, dove, nel 1544, alla vigilia di Pentecoste, fu protagonista di un evento sensazionale: un globo di fuoco - si dice - gli entrò nel petto attraverso la bocca.
Da quel momento iniziò a manifestare un'anomalia fisica: il suo cuore batteva forte e irregolare, udibile da chi gli stava intorno, e quando morì, l'esame del suo corpo rivelò che le sue costole si erano inarcate verso l'esterno, proprio a causa della pressione del cuore, che si era dilatato due volte e mezzo più del normale (il che avrebbe reso impossibile la sua sopravvivenza, mentre Neri visse 50 anni in quelle condizioni).
Da quella Pentecoste in poi, Filippo intensifica la sua opera di evangelizzazione della riforma "dal basso": frequenta giovani adulti e professionisti (non bambini o adolescenti, come spesso si pensa), va negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze, nei mercati, avvicinandosi alla gente con semplicità e con uno stile diretto, ironico, ma sempre profondo.
Nonostante la sua riluttanza, fu ordinato sacerdote nel 1551, all'età di 36 anni, ed esercitò il suo ministero con grande dedizione (trascorreva fino a dieci ore al giorno in confessionale).
Grande ammiratore del domenicano Girolamo Savonarola, prende le distanze dal suo rigorismo: per lui non sono le penitenze, le devozioni e le mortificazioni eccessive, ma la gioia, la semplicità e l'autoironia a costituire un antidoto all'orgoglio e un efficace aiuto alla crescita spirituale.
Amico e consigliere di diversi papi, morì il 26 maggio 1595. Fu canonizzato nel 1622 insieme a Ignazio di Loyola e Francesco Saverio (suoi amici e compagni a Roma), Teresa d'Avila e Isidoro il Labrador.
Eredità
Pur avendo un carattere effervescente, Filippo Neri amava la discrezione e cercava sempre di distogliere l'attenzione da se stesso, come fanno i veri leader (l'antropologo Paulo Pinto definisce il distacco come il trasferimento del carisma di un leader spirituale alla sua comunità dopo la sua morte, quando i seguaci si uniscono intorno ai valori che egli incarnava, non alla sua persona). In realtà, molto più famosi di lui sono stati i laici che sono cresciuti, umanamente e spiritualmente, sotto la sua egida. Basti pensare a musicisti come Giovanni P. da Palestrina o Giovanni Animuccia (anche il sacerdote e compositore spagnolo Tomás Luis de Victoria frequentava l'Oratorio).
Un'altra figura "oratoriana" degna di nota, oltre al santo sacerdote John Henry Newmanè il grande architetto spagnolo Antoni Gaudí, devoto di San Filippo Neri e assiduo laico dell'Oratorio di Barcellona (fu investito da un tram mentre si recava alle preghiere serali), di cui è in corso il processo di beatificazione.
In breve, Neri era caratterizzato da una spiritualità improntata alla giovialità, ma anche al non conformismo verso la propria persona o verso una norma preconcetta. Infatti, non volle mai essere considerato un "fondatore", sottolineando piuttosto che la santità è accessibile a tutti secondo le proprie caratteristiche e che la vera riforma spirituale, così come la vera penitenza, inizia con l'amore, con il sorriso, accettando la propria vita e quella degli altri per quello che sono e non per quello che vorremmo che fossero.
L'Oratorio
La Congregazione dell'Oratorio, nata ufficialmente nel 1575, era un'istituzione nuova per l'epoca, per garantire una forma stabile alla comunità sacerdotale cresciuta intorno a Filippo Neri, in cui i sacerdoti vivevano in comunità ma senza voti religiosi per dedicarsi al servizio dei laici e alle necessità dell'apostolato nell'Oratorio.
In una Roma ancora segnata dal sacco del 1527 e da una diffusa crisi morale e religiosa, Filippo, ancora laico, aveva infatti "inventato" l'Oratorio per favorire un rapporto quotidiano con Dio e con i fratelli nella fede, caratterizzato anche da incontri di preghiera con gli amici nella sua stanzetta nella chiesa di San Girolamo della Carità (dove abitava). Oratorio, infatti, deriva dal latino "os", bocca, per indicare il rapporto intimo, bocca a bocca, tra Dio e l'uomo. In questi incontri quotidiani, la Parola di Dio veniva trattata con familiarità e condivisa, con la partecipazione attiva dei laici (non come ascoltatori passivi, come nelle omelie della Messa) nella preghiera, nella riflessione e nella condivisione, cosa inaudita per l'epoca (come lo era la Messa quotidiana).
Musica
Una delle caratteristiche distintive dell'oratorio è la sua musica. Si parla infatti di musica "oratoriana" e addirittura di Filippo Neri come precursore del genere musicale noto come oratorio.
Il genio di Filippo fu quello di aver capito che la musica è un linguaggio universale e favorisce la diffusione del messaggio evangelico anche tra le classi popolari, allora analfabete e incapaci di comprendere il latino o la musica liturgica. Per questo motivo iniziò a utilizzare canti e melodie famose all'epoca, spesso modificandone i versi o la scrittura, o facendone scrivere di nuovi.
Da questa idea nacque il genere musicale dell'oratorio (spesso un'alternativa sacra all'opera), i cui compositori più famosi furono Carissimi, Charpentier, Haydn e, in ambito protestante, Handel (il suo è l'oratorio più famoso di tutti: il "Messiah") e Bach ("Passione secondo Matteo" e altri).
Spesso si è convinti che reintrodurre forme musicali barocche (o di nicchia, come il folk) al pubblico contemporaneo significhi ripercorrere i passi di San Filippo Neri: niente di più sbagliato. Tali opere sono certamente dei capolavori musicali, ma l'idea originale è quella di parlare alle persone in un linguaggio a loro familiare, quindi la musica pop/rock, o la musica musicale, in ambito non liturgico, sono le forme che più si avvicinano a ciò che pensava Filippo. È un po' quello che fanno oggi alcuni gruppi protestanti o cattolici (soprattutto carismatici): musicalità contemporanea, canzoni composte e arrangiate professionalmente, testi e significati cristiani. Tutto questo, però, al di fuori della Messa, dove, appunto, c'è la possibilità di "fare oratorio".
Devozione moderna
Filippo Neri è figlio della devozione moderna, un movimento di rinnovamento spirituale dei secoli XIV-XV che cercava di costruire una religiosità più intima e soggettiva, una "spiritualità individuale", in opposizione alla pietà collettiva del Medioevo.
La sua nascita si deve in particolare a Geert Groote (1340-1384), diacono e predicatore cattolico olandese, che adottò come sua Magna Charta il libro di Tommaso da Kempis L'imitazione di Cristo, incentrato sull'importanza del raccoglimento e della preghiera individuale, della lettura personale della Bibbia e dell'imitazione di Cristo nella vita ordinaria: la mistica incarnata nella realtà. Questo movimento si concentrò anche sull'apostolato dei laici, diffondendosi dall'Olanda al Belgio, alla Germania e alla Francia, quindi alla Spagna e all'Italia, e influenzando alcuni dei pilastri della Controriforma cattolica: Jan van Ruusbroec, Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, Ignazio di Loyola e, appunto, Filippo Neri, con Francesco di Sales come suo continuatore. Questi ultimi due ispirarono poi San Josemaría Escrivá a fondare l'Opus Dei.
Il concetto di devozione moderna ha trovato la sua legittimazione definitiva con il Concilio Vaticano II e l'esortazione apostolica "...".Christifideles Laici"Giovanni Paolo II.
Filippo Neri, come tanti santi prima e dopo di lui, è stato uno di quei leader, o padri nella fede, a cui Paolo invita a fare riferimento guardando all'esito della loro vita nell'imitazione della loro fede (non imitandoli direttamente, quindi). Direi poi che era un "Homo sapiens" per eccellenza, se teniamo presente che l'essere umano, fatto di terra (humus), è anche sapiens (dal latino "sapere"), termine che indica, più che l'erudizione, la sapienza: l'avere e il dare gusto.
Le tre H
Nella sua vita troviamo quelle che io chiamo "le tre H": "humilitas"; "humanitas"; "humour". Sono i tre ingredienti che permettono di essere "homo sapiens", quindi uomini e donne che hanno e danno gusto (e saggezza), e derivano tutti dalla stessa radice latina, "humus", che è anche la radice di "homo" (uomo):
"Humilitas" (umiltà): consapevolezza della propria limitatezza. Pur essendo fatti di terra, poveri e indifesi di fronte all'età, alla morte e a Dio, bisogna essere consapevoli della propria natura divina, con la dignità che ne deriva. La vera umiltà è quindi il giusto equilibrio tra terra e cielo, un sano realismo;
"Humanitas" (umanità): conseguente all'umiltà, è il rispetto per se stessi e per gli altri che può derivare solo dalla conoscenza di se stessi in relazione prima con Dio e poi con il prossimo. Solo con l'umiltà e l'umanità (relazione) si può essere dono agli altri;
"Humour" (umorismo): la vera umiltà, unita alla gioia della relazione con gli altri, ma soprattutto alla felicità di essere guardati e amati da Dio (che "ha guardato l'umiltà dei suoi servi") porta a un'inevitabile leggerezza: non ci si prende troppo sul serio e, quando si sbaglia, ci si perdona e si va avanti, ridendo dei propri e degli altrui difetti, ma un riso che non è derisione o scherno, ma semplicemente "chiudere un occhio".