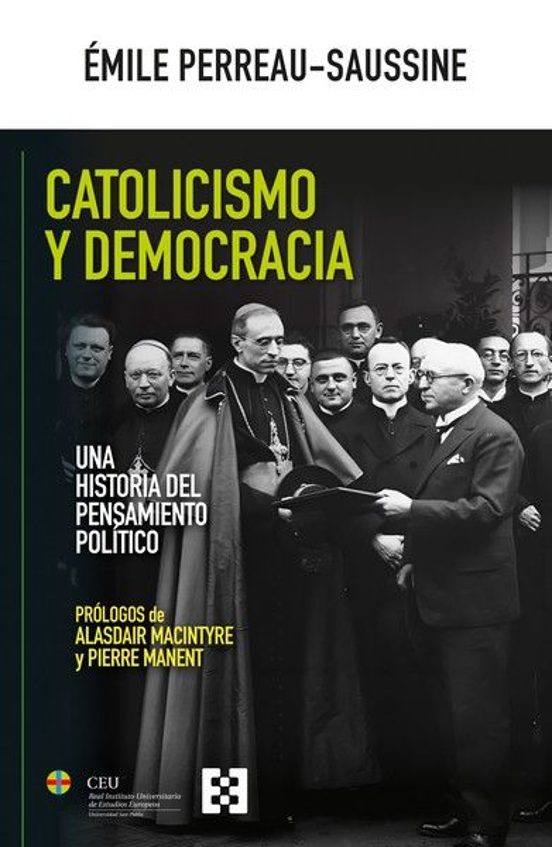Émile Perreau-Saussine (1972-2010) è stato successivamente professore di Politica e Studi internazionali all'Università di Cambridge e all'Istituto di Studi politici di Parigi (Sciences Po). La sua prematura scomparsa è stata molto compianta, poiché sia la sua carriera accademica che le sue pubblicazioni hanno preannunciato grandi progressi nelle scienze umane.
L'opera che ora presentiamo, Cattolicesimo e democrazia, vuole essere una vera e propria sintesi della storia del pensiero politico sulla linea della filosofia della storia politica nel senso più nobile e ampio del termine. Al termine di questa breve rassegna, il lettore comprenderà perché non offriamo fin dall'inizio una conclusione più straripante.
Indubbiamente, l'approccio di quest'opera è di assoluta attualità, in quanto viene sollevato in modo inequivocabile il rapporto tra libertà e democrazia e tra religione e democrazia dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri.
Naturalmente, leggendo questa interessante lezione di storia, diritto e teologia, non possiamo che ringraziare l'autore per la chiarezza di pensiero con cui ha spiegato alcuni momenti della storia, come la rottura dell'Ancien Régime, l'antico connubio tra il trono e l'altare, e per aver dato l'esempio della separazione tra Chiesa e Stato nel rispetto reciproco e nella piena accettazione del principio della libertà religiosa e del principio della libertà politica per i comuni cristiani che, insieme ai loro concittadini, sono coloro che stanno costruendo la società democratica occidentale.
Siamo pienamente consapevoli che il Sillabo del Beato Pio IX (p. 139) era una chiara dimostrazione di come la dottrina sociale della Chiesa richieda un costante aggiornamento, perché sempre l'inculturazione della Chiesa in ogni momento della storia richiede di scoprire ciò che è essenziale e perenne e ciò che è transitorio ed effimero.
Logicamente, il nostro autore, con grande agilità e semplicità, coglie l'occasione per far luce su questioni che per secoli sono state complesse e complicate: “questa è la storia e questo è il modo in cui l'abbiamo raccontata”.
Libertà, democrazia e religione: un approccio storico
Come c'è stato un tempo in cui la natura confessionale dello Stato sembrava fondamentale perché la Chiesa avesse libertà d'azione e i mezzi materiali necessari per evangelizzare il popolo cristiano ed energizzarlo affinché fosse sempre un buon figlio di Dio e della società, così è arrivato il tempo della deconfessionalizzazione delle nazioni con l'affermarsi della democrazia e il progredire della secolarizzazione e, come dice il detto tedesco: “l'aria della città rende l'uomo libero”.
Émile Perreau-Saussine concentrerà il suo discorso sullo studio e sul confronto tra il Concilio Vaticano I e il Vaticano II, sottolineando l'importanza del papato nell'illuminare le coscienze e il capitale della libera azione dei cristiani comuni che devono essere, come diceva il Vaticano II, “l'anima della società terrena”. Inoltre, il nostro autore concentrerà la sua ricerca sulla Francia e recentemente: “La Francia ha unito la vita politica, religiosa e intellettuale con un'energia non comune, dando ai grandi eventi della sua storia una rara fisionomia” (p. 29).
Dopo aver affrontato problemi come la costituzione civile del clero, la diffidenza degli illuministi e il grave e complesso problema del giansenismo, si occuperà del gallicanesimo: “L'affermazione dell'autonomia temporale non implicava la secessione religiosa. La Francia rimaneva parte della Chiesa universale e riconosceva l'autorità dei concili universali” (p. 68).
Ci soffermeremo poi sulla Rivoluzione francese e sulla sua conseguenza fondamentale: la radicale separazione tra Chiesa e Stato con cui la Francia ha affrontato il XX secolo e le guerre mondiali (p. 176), portando la fede all'interno delle coscienze e, allo stesso tempo, con un dispiegamento senza precedenti di ordini e congregazioni religiose nella loro opera missionaria, sia nelle città che nei territori di missione e nell'esercizio delle opere di misericordia corporali e spirituali che hanno riempito la Francia di istituzioni che hanno dato energia alla vita della Chiesa e della società.
Allo stesso tempo, la gente guardava a Roma per avere una guida per le coscienze nella società liberale, nello sviluppo industriale e nella dottrina sociale della Chiesa. Certo, la scienza, l'industria e la tecnologia si sviluppavano, ma l'uomo aveva bisogno di Dio e dei sacramenti: “In un mondo in subbuglio, il papato manifestava la permanenza di una salda identità. In un mondo che faticava a trovare il suo principio organizzatore, il papato appariva come l'apice di una gerarchia, una forza stabile e organizzata” (p. 108).
Secolarizzazione, laicità e protagonismo dei laici
Émile Perreau-Saussine inizia la seconda parte del suo libro con un confronto tra laicismo intollerante e laicismo liberale (p. 167). 167), per terminare studiando il Concilio Vaticano II e dando ai laici cristiani il vero peso della Chiesa di fronte al terzo millennio del cristianesimo che stiamo iniziando, non solo attraverso la chiamata universale alla santità espressa nella Costituzione dogmatica “Lumen Gentium” (n. 11), ma soprattutto attraverso la costituzione “Gaudium et spes”, in cui invita i laici a illuminare il mondo dall'interno (n.43).). Logicamente, dovevano cominciare col superare l'ateismo basato su un razionalismo scientista” (p. 175).
È molto interessante che Émile Perreau-Saussine dedichi un'ampia parte del suo libro allo studio di un canone del Codice di Diritto Canonico del 1983, ossia il can. 285, § 3, che non era certamente presente nel Codice del 1917: “ai chierici è proibito accettare quelle cariche pubbliche che comportano la partecipazione all'esercizio dell'autorità civile”. È quindi chiaro che l'azione dei chierici cattolici nella vita pubblica dovrebbe davvero lasciare il posto ai laici e che ogni clericalismo dovrebbe essere evitato (p. 233). Poco dopo affermerà: “La Chiesa è diventata meno clericale perché non ha più sentito il bisogno di opporre il cattolicesimo del clero alla corruzione dei laici” (p. 245). Molto interessante è la difesa da parte del nostro autore della libertà di educazione (p. 253) e persino l'affermazione: “Lo Stato deve servire Dio a modo suo: legiferando con giustizia per il bene comune” (p. 254).
Cattolicesimo e democrazia