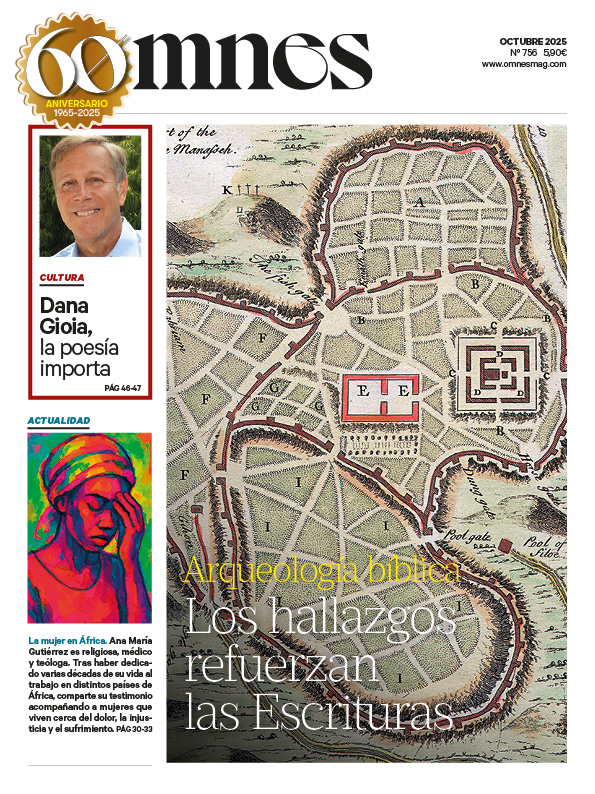Chi si avvicina all'opera poetica di Dana Gioia - a sfondo metafisico e basata su un autentico realismo visionario - scopre che vi sono due chiavi di lettura fondamentali. La prima è il suo legame con il Nuovo Formalismo, Il Nuovo Formalismo, movimento americano sorto in reazione alle predominanti tendenze avanguardistiche degli anni Ottanta e Novanta, trovò in Gioia non solo il suo più importante rappresentante ma anche il suo più lucido teorico. Lungi dal promuovere un semplice ritorno alla metrica tradizionale, il Nuovo Formalismo ha cercato di rinnovare l'attenzione per la forma e di salvare la musicalità del linguaggio, sia nei versi a rima baciata che nel versolibrismo. Per Gioia, la poesia è una forma d'arte profondamente legata al canto. Come egli stesso afferma: “Utilizza il suono e il ritmo per creare una connessione fisica con l'ascoltatore ed evocare un significato che va oltre le parole.".
La seconda chiave è la sua dimensione spirituale, in particolare le sue radici cattoliche, anche se la sua opera non contiene espliciti riferimenti religiosi a temi tradizionali. Gioia stesso ha risposto a questa domanda, posta sul perché la sua identità di poeta cattolico sia passata inosservata per tanto tempo. La sua risposta è stata chiara: “La maggior parte dei lettori è molto letterale e si concentra soprattutto sull'argomento. Poiché non ho scritto poesie sulla crocifissione o sulla Vergine Maria, non hanno mai pensato che fossi un poeta cattolico. Ciò che rende cattolica la mia poesia è la visione del mondo, l'uso sacramentale dei simboli, il ruolo redentivo della sofferenza, la compenetrazione del sacro e del mondano e, cosa forse fondamentale, la convinzione che la verità e la bellezza siano interdipendenti. (...) Scrivo partendo dai dettagli quotidiani della vita reale. Non dovrebbe essere necessario visitare il Vaticano per percepire il divino. È ovunque, se si sa come guardare”.”.
Infatti, Gioia non predica dalle sue poesie, né si rifugia in gesti liturgici. Il suo sguardo cerca il trascendente nel luogo comune, l'eterno nel quotidiano. È forse lì che la sua voce raggiunge una delle sue più grandi singolarità: in quella capacità di creare bellezza con profondità, senza solennità o clamore, ma con una fedeltà assoluta alla musica interiore del linguaggio.
Beatitudini
Precisamente, il suo poema più cattolico - secondo l'espressione dell'autore stesso - è Preghiera del solstizio d'inverno, un titolo che allude al giorno più corto e buio dell'anno, simbolo ancestrale di raccoglimento, attesa e speranza nella resurrezione. La poesia in questione recita: “Benedetta la strada che ci fa vagare / Benedetta la montagna che ci sbarra la strada / Benedetta la fame e la sete, la solitudine e il desiderio / Benedetta la fatica che ci consuma senza fine / Benedetta la notte e l'oscurità che ci acceca / Benedetto il freddo che ci insegna a sentire / Benedetto il gatto, il grillo e il corvo / Benedetto il falco che divora la lepre / Benedetti il santo e il peccatore, redenti l'uno dall'altro / Benedetti i morti, pacifici nella loro perfezione / Benedetti i morti, pacifici nella loro perfezione / Benedetti il santo e il peccatore, redenti l'uno dall'altro / Benedetti i morti, pacifici nella loro perfezione / Beato il falco che divora la lepre / Beati il santo e il peccatore, redenti l'uno dall'altro / Beati i morti, sereni nella loro perfezione / Beato il dolore che ci umilia / Beata la distanza che impedisce la nostra gioia / Beato il giorno breve che ci fa desiderare la luce / Beato l'amore che scopriamo quando lo perdiamo".
Il poeta stesso ha descritto questo testo come “una serie di beatitudini che elogiano la sofferenza e la rinuncia necessarie per metterci in guardia spiritualmente, da cui si celebra la natura trasformativa e redentiva della sofferenza, una delle verità spirituali centrali del cristianesimo, nonché una di quelle che si dimenticano facilmente nella nostra cultura consumistica e materialista. È anche una poesia che parla di come affrontare la dura realtà della nostra esistenza. La nostra società del benessere cerca di negare la sofferenza, a meno che non possa vendere una pillola o un prodotto che la bandisca.".
Così, senza solennità o posizioni dottrinali, Gioia offre una preghiera che nasce dal buio, una voce che cerca un senso in mezzo al dolore e che afferma, con la forza del linguaggio poetico, che anche lì - nel più inospitale - può abitare il divino.
Temi intimi, esistenziali e culturali
Dello stesso stile sono molte altre sue poesie, in cui affronta temi intimi come l'amore di fidanzamento - in Matrimonio di lunga durata, per esempio, difende la sua fedeltà coniugale; piangendo la morte del figlio - per esempio, difende la sua fedeltà coniugale; ePentecoste è un testo straziante che funge da vetrina, in cui si intrecciano senso di colpa, impotenza e una fede spezzata ma persistente, e in cui la morte è presentata come una trasformazione radicale, un'oscura “pentecoste”; oppure la memoria familiare e le radici personali, come in Ritorno a casa, Lo sfondo di molte delle sue poesie è il solito sfondo di molte delle sue poesie.
Esplora anche dimensioni esistenziali attraverso forme simboliche o fantasmagoriche, in cui oggetti, luoghi o anime dialogano con il personaggio poetico, generando un'atmosfera di straniamento carica di risonanze metafisiche. A questo si aggiunge una riflessione sulla natura stessa del linguaggio che, nella sua opera poetica, non è solo uno strumento espressivo, ma anche la sostanza stessa della realtà e un veicolo verso il trascendente. A questo proposito, la sua poesia più eloquente è Parole, Suggerisce che l'esistenza supera ciò che le parole possono comprendere, anche se il linguaggio rimane essenziale: “... il linguaggio rimane essenziale...".“Dare un nome significa conoscere e ricordare”Dice che la fede è necessaria per penetrare l'entità stessa del reale.
Presenza del sacro
L'opera poetica di Dana Gioia va dunque compresa alla luce delle due chiavi di lettura già citate: il rinnovamento formale - ereditato dalla Nuovo Formalismo- e una visione spirituale profondamente incarnata, sostenuta da una sensibilità cattolica non formulata, ma costitutiva. Da questa duplice prospettiva, è legittimo intenderlo come un poeta sacramentale, e non perché impiega, come ho detto, immagini religiose convenzionali, ma perché la sua poesia esprime una convinzione essenziale - e spesso controculturale - che il divino abita nel reale, nello specifico, nell'ordinario.
In un'epoca dominata dalla frivolezza culturale, dalla superficialità estetica e dall'abbandono dello spirituale, l'opera di Gioia si pone come silenziosa ma ferma affermazione della dignità umana. Nei suoi versi - musicali, profondi, illuminanti - risuona la certezza che la bellezza, quando è autentica, non è un mero ornamento, ma un percorso rivelatore verso una verità più sublime.