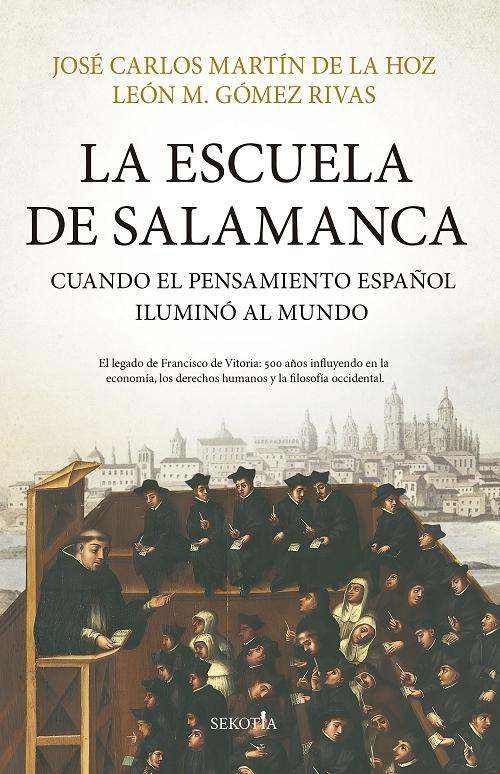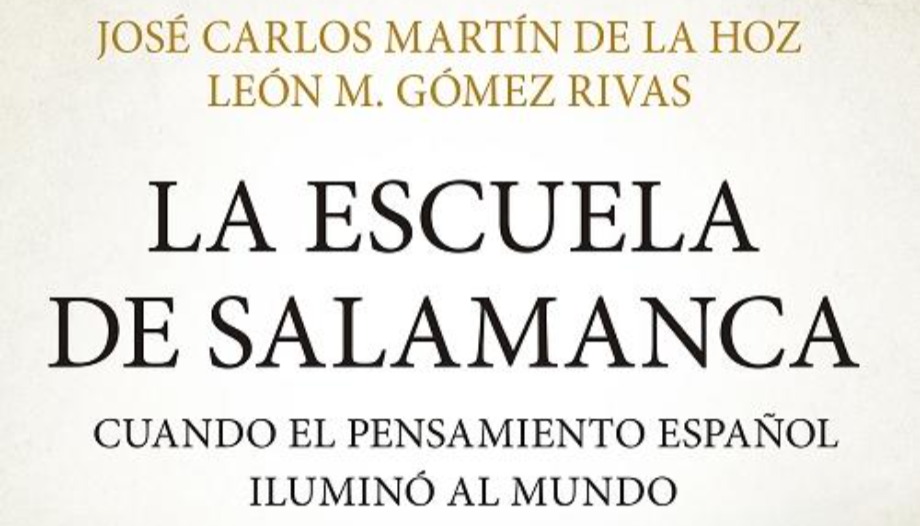Qualche giorno fa leggevo un interessante lavoro di un professore di storia della teologia dell'Università di Oxford, Alister E. McGrath (1953), sulla dottrina cristiana come vero e proprio laboratorio di fede in cui trovare nuove formule per presentare il cristianesimo agli occhi degli uomini in modo nuovo e attraente.
Non basta certo criticare ciò che non va nella società, negli approcci culturali altrui o nella vita degli altri. Dobbiamo entrare nel laboratorio della dottrina cristiana e cercare nella ricchezza della rivelazione cristiana nuovi approcci, idee attraenti: "Se il cristianesimo deve sopravvivere, dovrà offrire qualcosa che sia personalmente trasformativo ed esistenzialmente plausibile, che permetta un modo di vivere significativo, se vuole fare appello ai nuovi paesaggi culturali che attendono il futuro" (Alister E. McGrath, Il laboratorio della fede, p. 212).
Dopo la caduta di Costantinopoli e la perdita dell'Impero bizantino nel mondo occidentale, a Firenze, Bologna e Roma in particolare, sorsero numerosi artisti, scultori, pittori, architetti, musicisti e scrittori che, alla luce della ricchezza della letteratura classica greca e latina, rilanciarono l'idea di una civiltà costruita sulla dignità umana.
L'uomo divenne il centro della vita culturale, politica e persino religiosa. L'uomo, creato e redento da Dio, libero, poteva e doveva rendere gloria a Dio. Seguaci di Marsilio Ficino e della corrente neoplatonica, che cercò di riportare in dialogo con il cristianesimo, Pìco della Mirandola e Gianezzo Manetti recuperarono la tradizione greca e latina, nonché la teologia dell'interiorizzazione agostiniana, concentrando il loro interesse sulla definizione della dignità associata all'incarnazione e non tanto alla creazione.
La concezione antropologica adottata da queste correnti filosofiche invitava a contemplare la persona nella sua capacità di vivere l'unione con Dio, ma concentrandosi non tanto sull'origine della persona e sulla sua dignità, quanto sulla sua reale potenzialità, sulla capacità di sviluppare questa facoltà di incontro mistico con Dio.
In quegli anni furono scritti molti trattati di antropologia e, soprattutto, l'uomo fu posto come misura di tutte le cose, come direbbe Leonardo Da Vinci. Infatti, "Dignità dell'uomo" è il titolo di un'opera di Pico de la Mirandola (1486) e anche di Ferrán Pérez de la Oliva (1546).
L'ingresso del Rinascimento e dell'umanesimo nelle università portò a una rettifica di questo umanesimo pagano diffuso in tutte le raffinate corti d'Europa, con troppe tracce di filosofia stoica e di Machiavelli.
In questo contesto di riforma della Chiesa - che comprendeva gli ordini e le congregazioni religiose, il clero regolare e secolare, i concili e, in definitiva, tutto il popolo di Dio - fu promossa anche una trasformazione interna. Questo comprendeva il rinnovamento della teologia, del diritto, della spiritualità e degli studi biblici e filologici, che culminarono nella nuova versione della Vulgata, la Septuaginta-Clementina.
Il vertice dell'umanesimo cristiano saranno i documenti del Concilio di Trento e le sue espressioni pastorali: i seminari, il messale di San Pio V e il catechismo romano o dei parroci.
Tra pochi mesi si celebrerà il V centenario dell'inizio del magistero di Francisco de Vitoria presso la Facoltà di Teologia dell'Università di Salamanca. Sia lui che i suoi primi discepoli, Domingo de SotoMelchor Cano, formerà una pleiade di docenti che influenzerà tutte le università d'Europa e d'America, portando un unico spirito e un nuovo modo di fare teologia: quello della Scuola di Salamanca.
Tra le altre opere in corso di pubblicazione, vorrei citare quella che abbiamo recentemente pubblicato con León Gómez Rivas, professore presso l'Università Europea di Edizioni SekotiaL'origine e lo sviluppo del progetto si trovano lì in dettaglio.
Francisco de Vitoria, attraverso la sua cattedra di Salamanca, fu all'origine di una vera e propria scuola di teologi, molti dei quali provenienti dall'Ordine di San Domenico, che affrontarono le prime sfide umane, teologiche e morali del tempo, causate dall'irruzione del protestantesimo con le sue varie correnti, dalla scoperta, colonizzazione ed evangelizzazione dell'America e dalle conseguenze economiche e sociali della prima globalizzazione.
È interessante soffermarsi un po' sul significato della Scuola di Salamanca, poiché è un luogo comune attribuirle la fondazione del diritto internazionale e la sua opposizione ai titoli esercitati da Carlo V per la sua presenza in America, e poco altro.
Si tratta di una scuola teologica e giuridica perché ha basato tutte le sue argomentazioni, lezioni e opinioni sul concetto di dignità della persona umana. Non solo con la capacità di prendere decisioni morali, ma veramente come figli di Dio e dotati di personalità giuridica e teologica. Promuovevano i diritti degli indiani, sia di quelli che aderivano liberamente alla fede cristiana sia di quelli che non lo facevano.
Le conseguenze sono immense: la libertà e la responsabilità di gestire l'economia e di globalizzarla, la rimozione degli ostacoli economici e delle paure dell'attività commerciale. Il rispetto delle leggi del mercato, dei prezzi equi, lo sforzo di ridurre il carico fiscale dei re e delle corporazioni municipali.
Forse la lettura di questo libro ci aiuterà a comprendere più a fondo le caratteristiche dell'umanesimo cristiano, che è sopravvissuto praticamente fino ai giorni nostri, così da poter affermare che lo spirito di Vitoria è rimasto latente fino ad oggi.
La Scuola di Salamanca. Quando il pensiero spagnolo illuminò il mondo