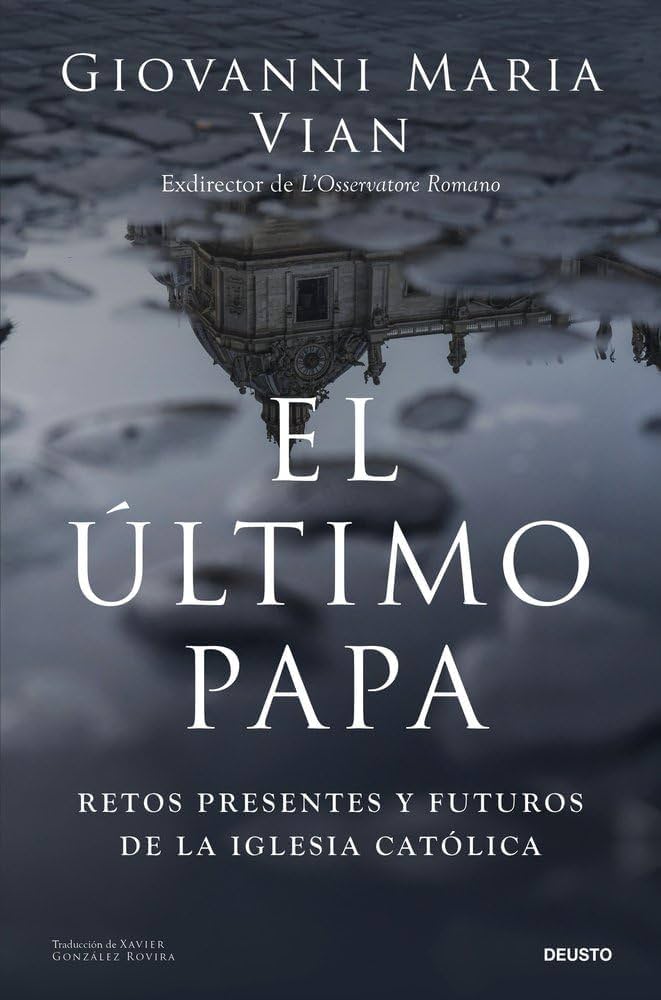Giovanni Maria Vian, professore di storia della La Sapienza di Roma ed ex direttore di L'Osservatore Romanoha scritto un'interessante opera per metà storica e per metà giornalistica sullo sviluppo del papato nel XX e XXI secolo, concentrandosi sul lavoro e sull'organizzazione della Curia romana. Il libro è presentato giornalisticamente come un'allegoria della famosa profezia apocrifa di San Malachia sull'ultimo papa che avrebbe regnato nella storia e che, "teoricamente", avrebbe inaugurato la fine del mondo e che, secondo la profezia, si sarebbe chiamato Giovanni XXIV. In realtà, a parte la copertina, il prologo e l'epilogo, il libro è un'opera di storia basata su fonti documentarie provenienti dagli Archivi Vaticani e su testimonianze di diverso rigore.
Una lettura della Chiesa
Il libro è stato presentato da alcuni organi di stampa come una critica ad alcuni aspetti del pontificato dei Papi recenti, da San Giovanni Paolo II ad oggi, anche se in realtà si tratta di un'analisi di valore variabile.
In effetti, il professor Vian, conoscitore della Curia romana e della storia contemporanea della Chiesa, fa eco a un apprezzamento che è stato abbondantemente sviluppato dai grandi intellettuali cristiani della storia recente, come Merry del Val, Romano Guardini, Hans Urs Von Balthasar e Rahner, Ratzinger e più recentemente da Andrea Riccardi.
Secondo Vian, la Chiesa dovrebbe abbandonare lo stile e i modi della società del cristianesimo, cioè quelli corrispondenti alla connivenza con lo Stato che è esistita dai tempi dell'imperatore Costantino fino ad oggi, per riconoscere che la separazione tra Chiesa e Stato è irreversibile e che le radici cristiane della società stanno scomparendo a grande velocità, per entrare a pieno titolo e nel giro di pochi anni in una nuova civiltà e cultura globalizzata post-cristiana.
In questo senso, quando San Giovanni Paolo II affermava che la nuova evangelizzazione era "nuova nel suo ardore, nel suo metodo e nelle sue espressioni", si riferiva a una società ancora con radici cristiane che poteva essere "de-secolarizzata" e ridiventare cristiana in misura considerevole, cioè una società umana ancora con radici cristiane fondate sul Vangelo, sulla filosofia greca e sul diritto romano.
Chiesa e dialogo con il mondo
Sicuramente, anche se non lo dice esplicitamente, quello che Giovanni Maria Vian propone, in sostanza, è l'opportunità di fare un nuovo Concilio Vaticano III in dialogo con il mondo di oggi. Riscrivere la "Gaudium et spes", analizzare la società occidentale di oggi per aiutarla a trovare approcci educativi, antropologici, filosofici e spirituali che rivalutino la dignità della persona umana e aprano orizzonti di speranza per una società in declino. Vuole che la Curia esca dall'autoreferenzialità (p. 205) e torni allo Stato di diritto (p. 213).
È importante rendersi conto che la società liberale, così come quella socialdemocratica, è tramontata e che stiamo andando verso una nuova cultura e civiltà in cui i parametri culturali e sociali sono diversi.
Bisogna scoprire che ci sono enormi strati della società odierna che non hanno interessi più grandi dell'autoaffermazione personale, dell'autonomia morale, del piacere e della comodità, e che il primo mondo, in realtà, disprezza la solidarietà e l'emigrazione perché è diventato crudelmente non solidale proprio perché ha abbandonato i valori spirituali.
La società del primo mondo si sta autodistruggendo ad alta velocità: valori fondamentali come l'amore, la famiglia, l'amicizia, il lavoro, la cultura, la serenità di giudizio, la visione spirituale e trascendente, e persino l'ecologia e l'ambiente, la pace.
La soluzione
Vian sembra dimenticare che la Chiesa cattolica ha la soluzione: la persona umana e divina di Gesù Cristo e la sua dottrina salvifica. La sua capacità di trascinare e trasformare, di accendere e aprire orizzonti di felicità, di amore illimitato e di preoccupazione per gli altri, la famiglia, il mondo, i bisognosi, gli scartati. Benedetto XVI l'ha detto in modo molto esplicito: "Abbiamo creduto nell'amore di DioÈ così che un cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita. Non si diventa cristiani per una decisione etica o per una grande idea, ma per l'incontro con un evento, con una Persona, che dà un nuovo orizzonte alla vita e quindi un orientamento decisivo" (Deus Caritas est1).
In ogni caso, Vian ci ricorda che è necessario riscrivere parte della dottrina cristiana per dare una risposta di Cristo ai problemi reali che affliggono gli uomini e soprattutto quelli delle classi dirigenti di questo nostro mondo: una nuova antropologia, attraente e coerente con la dignità di figli di Dio, dotati di libertà e dignità (p. 25).
A questo proposito, Vian dedicherà alcune pagine per evidenziare il documento finale con cui il Papa ha fatto proprie le conclusioni del "sinodo della sinodalità" il 24 novembre 2024, pochi mesi prima della sua morte. Questo straordinario documento post-sinodale si collega molto bene con le sensibilità attuali, anche con altre confessioni religiose e nell'organizzazione sociale dell'economia - dell'impresa - e nel modo di lavorare in gruppo che si è imposto. Proprio il documento finale, ha sottolineato Vian, ci parla di mettere le spalle al muro e di sentire la Chiesa come propria. Allo stesso tempo, i vescovi di tutto il mondo e il Papa, come padri di famiglia, veglieranno sul corso della Chiesa universale (p. 39).
Logicamente, molte delle proposte futuriste che vengono esposte in quest'opera sono del tutto opinabili e toccano punti sensibili della tradizione della Chiesa, per questo vanno prese liberamente, così come sono state espresse naturalmente, ad esempio, la proposta di distruggere le opere d'arte prodotte da alcuni artisti del nostro tempo che sono invischiati in terribili casi giudiziari (p. 47). Infine, affronterà direttamente la riforma della Curia pontificia, i suoi metodi di lavoro e il suo contributo di idee che continua dal codice del 1917 (p. 98).
I commenti sull'Opus Dei sono parziali, imprecisi e soggetti a una falsa dinamica: l'Opus Dei non ha mai voluto essere un'eccezione, né vivere lontano dai vescovi, né essere un'istituzione di potere, ma servire la Chiesa e le anime (p. 218).
L'ultimo Papa. Sfide presenti e future per la Chiesa cattolica.