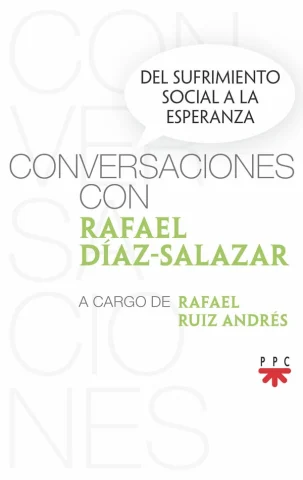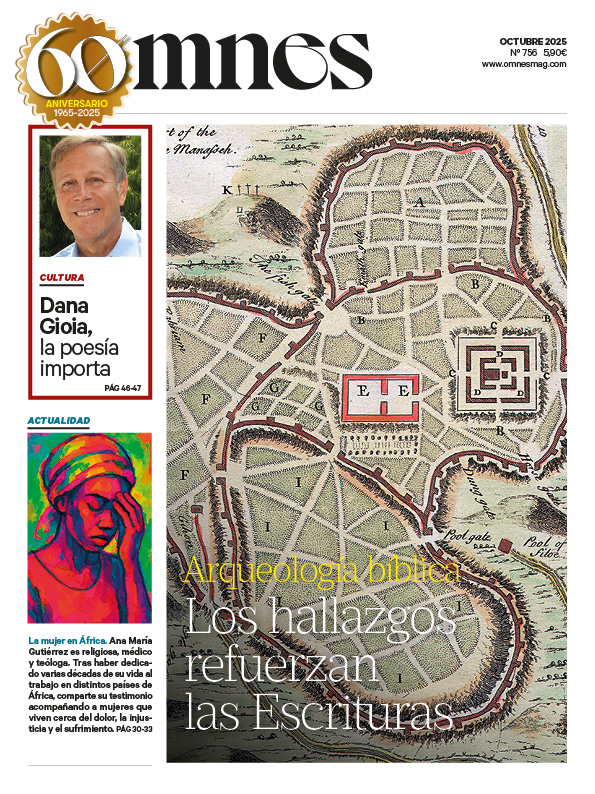Rafael Ruíz Andrés, professore di Sociologia religiosa all'Università Complutense di Madrid e uno dei nostri più prestigiosi sociologi accademici attuali, ha pubblicato su PPC i risultati di un interessante dialogo con il quasi emerito professore di Sociologia Rafael Díaz-Salazar, svoltosi tra i primi mesi del 2024 e la prima settimana di aprile del 2025, quando Papa Francesco era ancora in vita.
I coautori del libro sono persone di rilievo nel mondo accademico della sociologia dell'Università Complutense di Madrid. Innanzitutto il bravo intervistatore, Rafael Ruiz Andrés (Palencia 1991), prestigioso professore della suddetta università e autore di un'importante tesi di dottorato già pubblicata con grande successo sulla secolarizzazione in Spagna durante il XX secolo.
L'intervistato è Rafel Díaz-Salazar (Ciudad Real 1956), professore di sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociologia dell'Università Complutense di Madrid, un'autorità nel campo della sociologia religiosa e politicamente segnato come cattolico di sinistra e impegnato nel cristianesimo nel PSOE e, più recentemente, nell'ecosocialismo internazionale. È autore di importanti lavori in questo campo su Antonio Gramsci e, naturalmente, del suo interessante studio "El factor católico en la política española. Del Nacionalcatolicismo al laicismo, in PPC nel 2006 e altre opere di sociologia religiosa che sono state presenti nella Transizione democratica in Spagna e che spiegano la rapida crescita del socialismo in Spagna in quel periodo, negli anni Settanta.
I rivoluzionari cristiani: fede e impegno sociale
Fin dalle prime pagine, Rafael Díaz-Salazar non ha vergogna di spiegare la sua conversione al marxismo, la sua coscienza di classe, il suo impegno per la giustizia e l'azione sociale dalla giovinezza a oggi, sempre con un tenue legame con il cristianesimo: "Sono il frutto dell'operaismo cristiano della HOAC" (15). Interessante nella vita personale di Ruiz-Salazar è la confusione tra la vita di preghiera personale e la pratica della formazione culturale e spirituale (30-31). Tutto ciò va di pari passo con la totale assenza di vita sacramentale e di devozioni eucaristiche o di lettura meditativa dei classici della spiritualità (256-257).
A Díaz-Salazar sembra che la religione sia mutata e sia diventata più personale o familiare e meno pubblica e ostensibile (47). Tutto ciò costituisce una rottura nell'unità di vita tra la fede in Gesù Cristo e la sua dottrina.
La sua visione storica della Chiesa è piena di luoghi comuni e di ignoranza: "la Chiesa si è alleata con il potere" (97), o quest'altra affermazione: "è stata una disgrazia che il protestantesimo non abbia potuto mettere radici nel nostro Paese" (66). Dimostra inoltre una grande ignoranza in materia quando afferma che l'Inquisizione espulse gli ebrei e i mori dalla Spagna (80, 89).
La sua conoscenza del tardo-franchismo si rivela quando afferma, da persona esperta in materia, che i due pilastri del regime erano l'Opus Dei e l'ACNdP. Semplicemente, il dittatore non si è mai lasciato dominare da nessuna istituzione o gruppo di persone che potessero metterlo in ombra e, inoltre, l'Opus Dei non aveva l'obiettivo di entrare in politica, né aveva lo scopo o la capacità di influenzare politicamente il regime, dal momento che non è mai entrato in politica, né aveva le persone o le istituzioni per farlo. È comprensibile che, se si sbaglia su una cosa così elementare e nota, quante volte si sarà sbagliato sulle sue teorie sociologiche in quest'opera (75).
Per quanto riguarda le fonti del suo pensiero, basta leggere l'elenco degli autori che egli stesso presenta per avere la conferma che ci troviamo di fronte a un autentico esponente dei "cristiani per il socialismo", in quanto, oltre a essere superficialmente credente, è impregnato della questione sociale, non solo marxista, ma anche impegnato nell'azione rivoluzionaria (16).
Ha poi aggiunto che per i giovani della sua età e della sua linea di pensiero il nord era "la fame di giustizia e la fame di Dio erano collegate e profondamente unite nel nostro essere. Eravamo rivoluzionari e cristiani allo stesso tempo (...). Cristiani rivoluzionari" (17).
Pagine più avanti riassume il suo impegno-vocazione: "dedicarmi all'impegno politico e all'azione diretta, come Gesù di Nazareth, per cambiare la realtà dell'ingiustizia e dello sfruttamento subiti dal mondo operaio" (20).
Poco dopo, sottolineerà come la sua lotta abbia preso forma nell'Università Complutense come professore di Struttura sociale in Spagna: "mi è sempre stato chiaro che dovevo camminare con due piedi: uno era lì e l'altro nel mondo dei movimenti sociali e di altre organizzazioni socio-politiche e cristiane per accompagnare la formazione degli attivisti e generare un'opinione pubblica critica" (23).
Sociologia della religione e sfide del cristianesimo
Logicamente, i due autori del libro finiranno per parlare come sociologi della religione e della nuova mappa della sociologia religiosa in Spagna, azzardano previsioni funeste per il cristianesimo, come la sua scomparsa. Tuttavia, offrono anche ogni tipo di possibilità, compresa quella che la Chiesa cattolica tragga vantaggio dal secolarismo imperante.
Può infatti accadere che lo Spirito Santo porti nei templi cattolici e nel calore delle famiglie cristiane uomini e donne e famiglie pagane che, nel calore della liturgia, scoprono il "Deus absconditus" all'interno dell'anima cristiana e delle chiese e la carità cristiana nelle sue molte e varie forme di opere di misericordia corporali e spirituali.
Diaz-Salazar sbaglia ad attribuire a Giovanni Paolo II la sconfitta della crescita dei cattolici nel voto di centro-sinistra. La dottrina sociale della Chiesa da lui rivalutata ha avuto la sua continuità in Papa Francesco. Forse la chiave è che Giovanni Paolo II, venuto dalla Polonia per combattere il marxismo come motore della vita politica, ha aperto gli occhi a molti attivisti di sinistra sull'antropologia anticristiana contenuta nel marxismo (78).
Conversazioni con Rafael Díaz-Salazar