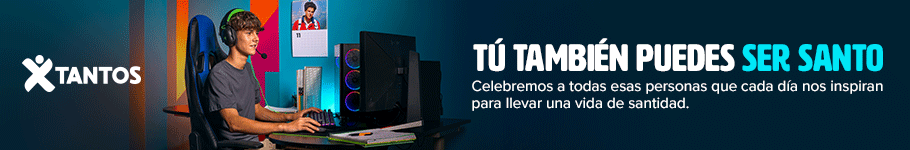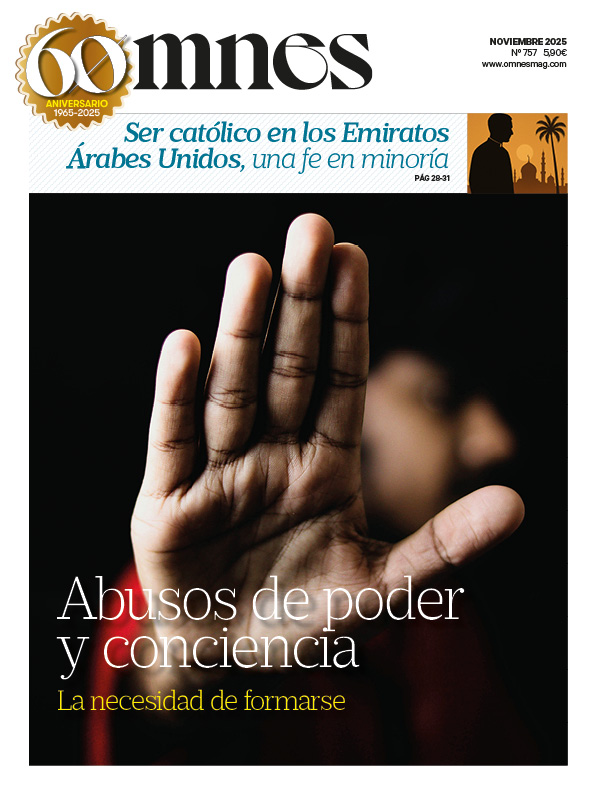Nel XV secolo si verificò una fugace unione dei cristiani. Fu durante il pontificato di Papa Eugenio IV. Una delegazione papale, di cui faceva parte Nicola Cusano, accompagnò l'imperatore Giovanni VIII e il patriarca Giuseppe nel loro viaggio da Costantinopoli a Roma. Il risultato fu l'unione della Chiesa ortodossa greca con la Chiesa cattolica (6.VII.1439).
Nicolás de Cusa, durante quel viaggio da Costantinopoli all'Italia, visse un'esperienza decisiva per la sua concezione filosofica. Vide come l'orizzonte del mare sembrasse estendersi come una linea retta e, tuttavia, quella retta facesse parte di un cerchio con un raggio molto grande, a testimonianza della forma sferica della terra. Quell'esperienza influenzò la sua opera. “De docta ignorantia”. Sappiamo che, a causa della nostra finitezza, non possiamo raggiungere la verità nella sua pienezza e precisione. E più siamo consapevoli della nostra ignoranza, più essa si trasforma in ignoranza colta, in saggezza, in una saggezza che parte dal dubbio ma che presuppone l'esistenza della verità che può essere fondata solo su un'intelligenza infinita, eterna e creatrice.
Il fallimento dell'unione tra Oriente e Occidente
L'unione delle chiese, proclamata il 6 luglio 1439 nella chiesa di Santa Maria dei Fiori a Firenze, fallì poco tempo dopo. Il metropolita Isidoro di Kiev la proclamò al suo arrivo a Mosca, ma fu arrestato per ordine del principe Vasili, che proibì alla Chiesa russa di accettare qualsiasi unione con i latini. Nell'impero bizantino, i vescovi greci, di ritorno da Firenze, trovarono un clima popolare avverso.
Sebbene l'unione fosse stata promulgata nella cattedrale di Santa Sofia il 12 dicembre 1452 alla presenza dell'imperatore Costantino XI, del legato papale e del patriarca bizantino, la reazione fu un violento tumulto, iniziato dal clero e dai monaci, che lanciarono il grido, seguito dalle masse: “Che il turbante dei turchi regni su Costantinopoli, piuttosto che la mitra dei latini!”.
Mezzo anno dopo, quell'urlo ebbe una triste realizzazione: il 29 maggio 1453 la capitale cadde in mano ai turchi, l'ultimo imperatore morì in battaglia e l'impero bizantino giunse al termine dei suoi giorni.
A Roma, Isidoro di Kiev, fuggito dalla Russia, e Bessarione di Nicea, diventati due cardinali della Chiesa, furono per anni il ricordo vivente di qualcosa che avrebbe potuto essere e non fu, perché gli uomini non lo vollero.
Meditando sulla caduta di Costantinopoli, Nicola Cusano concepì la sua grande visione di una futura riconciliazione universale: “De pace fidei” sulla pace della fede, completata prima del 14 gennaio 1454.
Seguendo Pio II verso la costa adriatica, dove si sarebbe riunita la flotta della crociata cristiana contro l'invasione turca, Niccolò subì l'ultimo attacco di una malattia cronica e morì a Todi (Umbria) l'11 agosto 1464. Tre giorni dopo morì ad Ancona il suo amico Enea Silvio, papa Pio II.
Nicea: radice e simbolo dell'unità cristiana
In questo Anno Giubilare dedicato alla speranza, spicca un anniversario molto significativo: ricorrono i 1700 anni dalla celebrazione del primo Concilio ecumenico, il Concilio di Nicea. Si tratta di un «pietra miliare», come sottolinea Papa Francesco nella Bolla di convocazione del Giubileo 2025. Per tutti i cristiani, rappresenta un evento con cui identificarsi e trovare l'unità.
È uno dei grandi capitoli della storia della Chiesa. Il Concilio fu convocato dall'imperatore Costantino nel 325 con il compito di preservare l'unità, «gravemente minacciata -come ricorda Francesco nel documento «Spes non confundit»– per aver negato la divinità di Gesù Cristo e la sua uguaglianza con il Padre». Il Concilio di Nicea, al quale parteciparono circa 300 vescovi, tra cui legati del Papa e rappresentanti della Chiesa orientale, condannò l'eresia di Ario. Da Nicea proviene un invito che è ancora attuale, rivolto a tutte le Chiese e alle Comunità ecclesiali: proseguire il cammino verso l'unità. I Padri conciliari utilizzarono «per la prima volta l'espressione Noi crediamo».
Il Concilio di Nicea nacque in seguito ai problemi sorti in alcune delle principali sedi episcopali d'Oriente, tra cui Alessandria e Antiochia. Il contributo dell'imperatore Costantino fu decisivo e cercò a modo suo l'unità, una pace religiosa che potesse garantire anche al popolo. È anche unità vedere che il Concilio di Nicea - oggi Iznik, città di pellegrinaggio - è in qualche modo legato a questo tempo giubilare di speranza.
Per le Chiese orientali, il Concilio di Nicea è il primo Concilio ecumenico. Questo evento è commemorato in quasi tutte le tradizioni delle diverse Chiese orientali nell'anno liturgico con una festa speciale. La dichiarazione che «Cristo è vero uomo e vero Dio» risponde all'eresia dell'arianesimo. L'espressione Filioque aggiunta dalla Chiesa latina al Credo niceno-costantinopolitano, ovvero che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, ha una connotazione precisa: si tratta di sottolineare questa natura divina del Figlio.
La questione del Filioque è stata una delle cause di dissenso tra le Chiese d'Oriente e d'Occidente. Nel XX secolo, grazie al dialogo ecumenico tra cattolici e ortodossi, è emerso chiaramente che non si tratta di un tema che causa divisione. Alcuni studiosi suggeriscono alla Chiesa latina di riflettere, valutare se sia possibile sopprimere il Filioque e tornare alla forma più antica.
Una Pasqua comune
Il Concilio di Nicea discusse anche la questione della data in cui doveva essere celebrata la Pasqua. Già nel IV secolo era stato espresso il desiderio di «celebrare insieme la Pasqua»: l'imperatore Costantino, riferisce Eusebio di Cesarea, voleva che i cristiani la celebrassero in un'unica data. Una delle decisioni prese dal Concilio di Nicea fu quella di non celebrare la Pasqua con gli ebrei.
Nel XII secolo, diversi canonisti bizantini aggiunsero anche «che la Pasqua non doveva essere celebrata prima degli ebrei». Oggi, nel calendario gregoriano, la Pasqua può precedere la Pasqua ebraica. Gli studiosi sostengono che ciò non fosse dovuto a motivi legati all'antisemitismo, ma al fatto che, dopo diverse distruzioni di Gerusalemme, anche gli stessi ebrei avevano perso il modo di calcolare con precisione la Pasqua. Ora, in questo anniversario che segna i 1700 anni dal Concilio di Nicea, si sta valutando l'opportunità di arrivare a «una data unica per la Pasqua».