Ciò che Dio dà agli uomini per la loro salvezza non sono doni, ma regali. Certamente, i mezzi di salvezza sono utili per raggiungerlo. Ma, al di là della sua utilità per ciò che possiamo ottenere, è il fatto che sono presenti a Dio. Piuttosto, non sono solo un ricordo, ma Dio è colui che è presente nei suoi doni, che sono i sacramenti e la preghiera. È a partire da questo stupore e dall'attesa di un incontro sorprendente che il cristiano deve considerare la ricezione dei sacramenti: sempre uguale e sempre diversa. In questo articolo ci riferiremo al confessione proponendo un nuovo modo di vedere le cose. Quando ci relazioniamo con gli oggetti, o addirittura con gli animali, possiamo prevedere tutto ciò che accadrà e padroneggiare la situazione. Quando l'incontro è personale, tuttavia, non tutto può essere previsto e dobbiamo essere aperti ad ascoltare l'altro e ad adattare le nostre interazioni. Se l'altro è Dio, l'apertura alla sorpresa è un requisito inevitabile. Non possiamo andare ai sacramenti con l'aspettativa che accada ciò che già sapevamo, anche se sappiamo che la confessione dei peccati porterà al perdono. Ogni incontro con il Creatore è ineffabile, unico e irripetibile, anche quando il penitente, i peccati e il confessore sono gli stessi.
Rivitalizzazione della confessione
Giovanni Paolo II ha incoraggiato il recupero della confessione convocando un sinodo e pubblicando nel 1984 l'esortazione apostolica Reconciliatio et paenitentiaMise in guardia dalla perdita del senso del peccato e riaffermò la dottrina del sacramento della penitenza. Di conseguenza, furono attuate numerose iniziative pastorali, come l'estensione dei tempi di confessione, il rilancio del confessionale e la catechesi sul peccato e sul perdono.
Oggi, sebbene la cultura della confessione sia stata rivitalizzata laddove sono state seguite le proposte del Papa polacco, la rivoluzione digitale e l'accelerazione dei cambiamenti nella società pongono nuove sfide e opportunità per una più profonda comprensione del sacramento. Stiamo vivendo cambiamenti costanti che si susseguono a rotta di collo. In questo senso, possiamo dire di appartenere a una società che vive in un ritmo accelerato perché deve adattarsi ai cambiamenti senza il tempo di metabolizzarli.
La crisi postmoderna
La pressione del sociale e del nuovo ha dato origine ad un soggetto iperstimolato e, di conseguenza, l'analfabetismo affettivo dovuto alla mancanza di interiorità. Sebbene il livello di benessere e la qualità dei servizi siano aumentati, è innegabile che si sia verificata una crisi antropologica, che si manifesta con personalità ansiose, profonde ferite emotive, solitudine, patologie psichiche e, purtroppo, un tasso di suicidi nei giovani sconosciuto in altri periodi storici.
La cultura del successo è degenerata in un rapporto disordinato con il lavoro e in una competizione permanente con i coetanei. Troviamo un soggetto emotivista e sradicato.
Implicazioni per la confessione
Alla luce di questa situazione culturale, è necessario sottolineare la conseguenza consolatoria del sacramento della confessione, affinché non diventi un luogo di frustrazione personale. Continuare a sottolineare la necessità di essere concisi e concreti nell'accusa delle colpe può avere la conseguenza di approfondire il volontarismo perfezionista che caratterizza i ragazzi del nostro tempo.
Avviamento
Da un lato, è necessario continuare ad approfondire il significato del peccato, come ammoniva Giovanni Paolo II. Oggi si tende a considerare la libertà senza distinguere tra la libertà e il peccato. naturale e spontaneo. Pensiamo che tutto ciò che viene da dentro di noi sia naturale e non ci consideriamo colpevoli di cattivi pensieri o cattive intenzioni. Quando compiamo azioni cattive, cerchiamo di colpevoli a cui attribuiamo la causa del nostro errore, o pensiamo che chiunque altro avrebbe agito allo stesso modo nelle circostanze. che ci ha portato di essere ingiusto. Si tratta di ciò che viene colloquialmente definito come il avviamento. Ad esempio, se reagisco in modo aggressivo e sproporzionato a un automobilista che mi incrocia indebitamente sulla strada, penserò che la colpa della mia reazione ingiusta sia sua o che chiunque altro avrebbe fatto lo stesso.
Utilitarismo
Inoltre, la cultura consumistica e il linguaggio utilitaristico hanno trasceso lo spazio economico e di mercato e hanno colonizzato aree come l'istruzione e la percezione personale. Byung Chul-Han, ad esempio, descrive l'uomo postmoderno come soggetto performante. Una persona sottoposta a una pressione sociale per l'efficacia e l'efficienza che la porta a vivere di fronte a se stessa secondo le richieste sociali di eccellenza nei risultati, a scapito del benessere personale e della cura delle relazioni.
Questa autostima può dare origine a una concezione del sacramento della confessione come luogo in cui rendere conto dei risultati insufficienti, con l'aspettativa di ottenere motivazione e forza per continuare a cercare di essere socialmente efficaci. È chiaro che la distorsione che sta alla base di questa visione del valore percepito e della vocazione personale genera cristiani ansiosi e frustrati perché non si sentono all'altezza della loro vocazione cristiana. Questo spiega l'insistenza di Papa Francesco sul fatto che la confessione dovrebbe essere un luogo di misericordia e non un'impalcatura di tortura psicologica e spirituale.
Consumismo
Inoltre, gli stili di vita consumistici si estendono al rapporto con i mezzi spirituali e danno luogo alla strumentalizzazione dei sacramenti, ai quali ci si rivolge per risolvere un problema o mantenere un precetto. La Messa domenicale è frequentata come un rapporto di scambio che eclissa la dimensione dell'incontro: si adempie al precetto con la conseguenza di ottenere la vita eterna, ma non c'è quasi partecipazione alla celebrazione del mistero di Dio, all'ascolto della sua Parola, ecc. Anche l'idea di andare a Messa "per confessarsi e ricevere la comunione" è data per scontata.
Qualcosa come l'approfittare di un due per unoanche se la confessione è affrettata, o durante la lettura del Vangelo o addirittura alla consacrazione. Questo comportamento rivela che, accanto all'innegabile buona intenzione del penitente, c'è una profonda mancanza di senso liturgico e di comprensione del sacramento. Ci si rivolge a per ottenere qualcosa invece di incontrare qualcuno.
Narcisismo
Un'altra distorsione tipica dei sacramenti del nostro tempo è l'atteggiamento narcisistico nei confronti del peccato. Il soggetto performante considera il peccato come un errore che avrebbe dovuto evitare e riconosce di non averlo fatto. Quando si accusa di questa colpa, può tenere conto più della sua imperfezione che dell'offesa a Dio. Può accadere, infatti, che chieda perdono per errori che non comportano alcuna offesa e trascuri i peccati che nascono da una ferita profonda, perché non sono evidenti nel suo comportamento.
Il narcisismo ci porta ad un'autoreferenzialità da cui anche Papa Francesco ci mette in guardia, in cui non distinguiamo il senso di colpache è uno stato psicologico e personale dell'essere, del coscienza del peccato che, partendo dal senso di colpa, lo riferisce alla relazione personale con Dio e passa dall'ambito psicologico alla dimensione teologica della relazione con il Creatore. Una caratteristica del narcisismo è l'apparenza di chiedere perdono a se stessi. per non essere stato come avrei dovuto.
Atrofie e ipertrofie
Tutte queste distorsioni legate al sacramento della confessione rivelano difetti ed eccessi del cuore della Chiesa. soggetto performante che vuole vivere la sua vita cristiana.
Il primo grande difetto è l'idea stessa di Dio. Il cristiano tende a vedere se stesso come qualcuno che deve essere all'altezza del compito della propria condizione e, come fanno i calvinisti, attribuisce al Creatore un'aspettativa di successo nella vita professionale, familiare, relazionale ed evangelistica, in base alla quale giudicherà la propria crescita nella santità personale. Questa visione errata di Dio sfocia in uno stato di accidia spirituale per mancanza di speranza o in una debole rigidità perfezionista, che riduce le sue lotte a ciò che può controllare.
Il secondo difetto è la concezione della grazia di Dio come un aiuto estrinseco per fare del bene che non si può fare con le proprie forze. Una sorta di vitamina spirituale con cui raggiungere livelli più alti di santità. Questo genera una profonda frustrazione quando ci si rende conto che la frequenza dei sacramenti non migliora i risultati ottenuti. Allora si angoscia, pensando che il suo problema sia la mancanza di fede, perché non confida abbastanza intensamente in essi. Poiché, ovviamente, la grazia non è un sostituto della libertà, e nemmeno ciò che la soggetto performante Alla fine, finisce per arrendersi e cercare di sintetizzare il suo senso religioso e la sua disperazione, con forme di comportamento incoerenti che aggravano ulteriormente la crisi. Alla fine, si traduce in un cristianesimo di forma che nasconde un agnosticismo sfondo.
Angoscia e fragilità cristiana
Gli eccessi della soggetto performante nel suo rapporto con Dio si può riassumere in una cosa: la paura. Per questo si confessa in modo ansioso, superficiale, ripetitivo e strumentale. È angosciato dai suoi peccati e vuole lavarli via come chi lava una macchia che riappare. Il rito della confessione diventa dispensabile ed egli ripete le parole come se fosse una formula magica per ottenere il risultato che si aspetta. Non cerca nemmeno di aprire la sua anima per mostrarla a Cristo, ma solo di dire ciò che lo affligge nella speranza di ottenere il risultato che si aspetta. le parole magiche di assoluzione, al fine di ricominciare da zero.
Dio non è indifferente a questa fragilità. Il suo amore per i figli lo rende attento e incline nei loro confronti. Così come l'impotenza e l'inettitudine di un bambino piccolo suscita nei suoi genitori tutta la tenerezza che li muove a una cura costante e incondizionata. La domanda di Dio all'uomo non è cosa avete fatto ma cosa c'è di sbagliato in te. Questa distinzione è fondamentale per comprendere la confessione, perché sappiamo cosa c'è di sbagliato in noi attraverso i sintomi, che si manifestano in ciò che abbiamo fatto. Ma la confessione non è un resoconto di ciò che abbiamo fatto di sbagliato, bensì la ricerca di ciò che abbiamo fatto di sbagliato. cosa c'è di sbagliato in me a partire da cosa ho fatto.
Dal peccato al danno
In altre parole, è necessario distinguere (senza separare) il peccato dalla ferita per capire che, nella confessione, Dio perdona i peccati che confessiamo, ma bacia le ferite dei suoi figli e rimane con loro. I peccati sono perdonati, ma le ferite rimangono e Dio in esse. Quindi l'aspettativa della confessione non è quella di arrivare un giorno a evitarli, ma di trasformare il peccato in un luogo di incontro d'amore. Come la malattia di un bambino è il motivo per cui i genitori si legano al figlio in modo più tenero, profondo e incondizionato, Dio ci ama come un Padre che ha legami più stretti con i suoi figli più bisognosi.
Non dobbiamo intendere il peccato come un'offesa che possiamo arrecare direttamente a Dio. C'è un abisso tra il suo Essere e il nostro. Per quanto grandi e intensi possano essere i nostri peccati, essi non arrivano fino a danni L'essere di Dio. Il motivo per cui c'è offesa è che l'amore si aspetta sempre una risposta. Non è vero che amare è non dare nulla in cambio. Essendo una relazione, ha sempre la speranza della reciprocità. È vero che il vero amore dà anche se non riceve nulla in cambio, ma questo non significa che non se lo aspetti. È proprio questa la vulnerabilità dell'amante: si espone liberamente alla possibilità di essere rifiutato o di non essere ricambiato. È la stessa logica del dono: chi lo fa si aspetta che l'altro almeno lo gradisca o ne sia contento. L'indifferenza o il rifiuto del dono sono un'offesa per chi lo fa. Il peccato come offesa a Dio consiste nel rifiutare o non accettare l'amore che ci offre. Nel dare i doni, Dio dà se stesso, come abbiamo detto all'inizio di questo articolo. In questo sta la sua vulnerabilità.
L'atteggiamento giusto
Pertanto, il modo giusto di confessarsi è quello di chi sta per ricevere un dono prezioso da qualcuno che lo ama molto. Questo motiva la confessione dei peccati - dopo un buon esame di coscienza, con l'opportuna distinzione del numero e del tipo di peccati mortali, eccetera - e l'apertura del cuore ad accogliere l'amore che Dio offre. Questo è il modo per superare la visione legalistico di mera responsabilità e le atrofie e ipertrofie di cui sopra.
Il avviamento ha dato origine a una confusione tipica dei nostri tempi, che consiste nell'identificare le scuse con la richiesta di perdono. Queste espressioni sono considerate sinonimi, mentre in realtà hanno significati opposti. Dis-accusa è riconoscere un danno causato a qualcuno, ma chiedere che non gli venga imputato perché si è verificato per ragioni che sfuggono al controllo del donatore. Ci si scusa quando si arriva in ritardo a un appuntamento a causa di un ingorgo, o di un malfunzionamento dei servizi di trasporto, e così via. Chi si scusa chiede qualcosa a cui ha diritto: se non ha colpa, non può essergli imputata. È giusto che venga concesso.
Al contrario, la richiesta di perdono nasce dal riconoscimento di una colpa imputabile all'agente. Chi chiede perdono implora qualcosa che non merita, perché ha agito ingiustamente per negligenza o dolo. Si pone quindi in una situazione di inferiorità e fa appello alla grandezza d'animo dell'offeso. Può concederglielo solo se ha amore per lui. al di sopra dei loro difetti e accetta generosamente di rimettere la colpa e di cancellare il rancore e il desiderio di vendetta, anche se l'offesa può aver provocato un danno irreparabile. Chi chiede perdono si umilia perché non pretende qualcosa che gli spetta, ma un bene che implora.
Il dramma del buonismo
Il buenista capisce che le cause delle sue cattive azioni sono al di fuori di lui perché, come abbiamo spiegato prima, confonde la causa con la causa scatenante. Questo lo porta a considerare la richiesta di perdono come una posizione di intollerabile debolezza e la richiesta di scuse deve essere riempita di argomenti, per cui non pone l'accento sull'offesa ma sulla buona intenzione che lo giustifica. La sua tranquillità deriva più dalla sua intenzione di non recidivare che dall'amore di chi lo perdona. Per questo la confessione manifesta e promuove la sua immatura intenzionalità, piuttosto che un reale abbandono alla misericordia di Dio.
Inginocchiarsi davanti a Dio, mostrare le proprie ferite e accusarsi dei peccati commessi è profondamente consolante perché si trova sempre il cuore di Dio pronto a perdonare e a trasformare. Dio non ci ama per ciò che facciamo di buono, ma perché siamo suoi figli e ci lasciamo amare. Nella nostra lotta per fare il bene riconosce la nostra buona volontà e ne è commosso, ma non ne ha bisogno per amarci. Per lui è più importante che ci lasciamo amare così come siamo, senza creare un'immagine di noi stessi sulla base di ciò che dovremmo essere, dovremmo essere.
Essere davvero bravi
Chi conosce se stesso con sufficiente profondità e maturità è consapevole della sua precarietà rispetto al desiderio di realizzazione, aggravato dall'infezione del peccato, che si manifesta nella deviazione dell'intenzione e delle motivazioni che lo muovono, anche quando agisce bene. Così, non si sorprende di fare cose apparentemente ma che, essendo fatte con cattive intenzioni o per motivi ingiusti, non lo rendono una persona migliore ma peggiore. Questa distinzione tra fare qualcosa di giusto e essere buoni è fondamentale per comprendere la confessione.
I rimproveri di Gesù ai farisei nel Vangelo riguardano soprattutto il fatto che essi compiono buone azioni, ma il loro cuore non è buono. I motivi sono la vanità, l'esercizio del potere o il disprezzo per gli altri, anche nel compimento dei loro doveri o nell'esercizio del culto. Nel contemplare le loro buone azioni si sentono degni del merito e della benevolenza di Dio. Gesù, tuttavia, rivolge loro le peggiori invettive e insulti: razza di vipere, sepolcri imbiancati, guai a voi, farisei, ipocriti, ecc.
Senza dubbio, il cristiano deve sforzarsi di fare il bene e di prendersi cura del mondo e degli altri. Tuttavia, non deve fare affidamento su questo per la sua santità o vicinanza a Dio. Deve essere consapevole della deviazione delle sue motivazioni e delle sue intenzioni nel fare cose cattive, indifferenti o buone, e rendersi conto che questa distorsione rovina la bontà personale che intendeva perseguire nella sua azione. La sua fragilità e l'infezione della ferita hanno bisogno della compagnia e della trasformazione che solo Dio può operare.
Bellezza nel dolore
È proprio in questa considerazione della sua mancanza di bellezza interiore che egli troverà Cristo nella sua Passione come -Il più bello degli uomini (Sal 45, 3), la cui bellezza è stata eclissata dal dolore (Is 53, 2). Gesù incarna il mercante di perle pregiate che, trovandone una di grande valore, vende tutto ciò che ha e compra quella perla (Mt 13, 45-47). Il suo vendere tutto ciò che aveva è l'abbassamento del Verbo di Dio a uomo e umiliato fino alla morte (Fil 2, 5) e la perla di gran prezzo è il cuore del peccatore.
Il penitente che si confessa con questa visione cerca di sentirsi apprezzato da Dio fattosi uomo, nonostante i peccati che offuscano la perla che è il suo cuore. Gioisce della misericordia inavvicinabile e della disperazione del Creatore stesso. Lascia che sia l'amore di Dio a considerarlo un uomo. bene nonostante tutto il male fatto. Da questo grato stupore nascerà uno sforzo naturale per fare le cose bene, ma non considererà il risultato dei suoi sforzi come il suo valore davanti a Dio.
Il vero me
Il perfezionismo ci porta a giudicare noi stessi secondo un'immagine idealizzata di noi stessi, portando all'insoddisfazione. Sebbene sia naturale aspirare alla pienezza, la maturità consiste nell'accettare la realtà con autenticità, così come ci vede Dio, che non pretende perfezione o efficienza. La vera maturità non consiste nel pretendere uno standard irraggiungibile, ma nel presentarsi con onestà, comprendendo che sbagliare e non raggiungere tutti i nostri obiettivi non è un'offesa.
Il tema della confessione non sono tanto gli errori quanto la rottura dei legami con Dio o con gli altri. Vale a dire, il disordine degli amori. L'immagine irreale di sé rende impossibile al penitente l'incontro con Dio, perché egli stesso è assente in questo incontro. Non è lui ad apparire, ma una falsa immagine di sé. Non c'è incontro, ma solo apparenza. Per questo non c'è nemmeno consolazione, ma angoscia.
Esame di coscienza
Le domande proposte come esame di coscienza possono servire come stampelle per gli zoppi. Sono un valido sussidio per chi non ha abilità o abitudine a trattare con Dio, ma sono inutili o addirittura controproducenti per chi è sano. Usare le stampelle quando si può camminare bene rallenta l'andatura e impedisce un movimento armonioso del corpo.
Allo stesso modo, chi esamina la propria coscienza a partire da un elenco di peccati non coglie le motivazioni e le intenzioni che hanno portato ad azioni apparentemente buone, ma che hanno sporcato il suo cuore e rotto i legami personali.
Dal senso di colpa alla coscienza del peccato
Il senso di colpa deve essere esaminato, e in questo consiste il discernimento, sulla base di relazioni personali significative. Vale a dire, passare dal senso di colpa alla consapevolezza del peccato, a causa dell'offesa a Dio o agli altri che può (o meno) rivelare questo senso di colpa.
Il cristiano postmoderno è affetto da ferite emotive e tensioni interiori, sottoposto a ritmi di lavoro e di vita che superano la sua capacità di adattamento e immerso in una cultura di competizione con i suoi simili. Corre il rischio di interpretare la sua relazione con Dio in modo individualistico e narcisistico e, di conseguenza, di rivolgersi ai mezzi di salvezza con una mentalità e delle aspettative che non corrispondono alla misericordia di Dio.
Cura pastorale di una confessione di guarigione
È urgente ripensare l'evangelizzazione senza minare l'integrità del dogma e della dottrina cattolica, ma piuttosto chiarendo gli aspetti del mistero della relazione di Dio con l'umanità che rendono giustizia all'amore di Dio per l'uomo: "... l'amore della Chiesa per l'umanità non è una questione del passato, ma del futuro".Abbiamo conosciuto e creduto all'amore di Dio per noi". (1 Gv 4,16). Questa emergenza richiede una pastorale molto centrata su Gesù Cristo, che dia la priorità alla relazione rispetto allo scambio, che dia ai fedeli un profondo significato liturgico e che si basi su un'antropologia in cui l'uomo è il primo a essere stato ucciso. essere è prima del esseree il essere prima del fare. I fedeli non devono cercare qualcosa in Dio, ma a qualcuno.
Il rito come splendore della misericordia
Lo stesso vale quando un uomo chiede alla sua ragazza di sposarlo. L'informazione non è sufficiente. L'intensità e l'importanza del momento devono essere espresse in un paesaggio appropriato, inginocchiandosi, offrendo un anello, ecc. Queste azioni permettono di vivere intensamente e vitalmente l'unione affettiva e proiettiva di queste persone. Il rito della confessione, come quello della Messa, è una bella gestualità dell'incontro tra il penitente e Dio. Le parole sono tratte dagli incontri tra San Pietro e Gesù che hanno segnato biograficamente la vita del primo Papa. Il penitente, inginocchiato, sente dal sacerdote che l'evento del suo perdono avviene nel suo stesso cuore. Inoltre, la formula di assoluzione fa appello alla Trinità, alla Vergine Maria, ai santi, ecc. ed è data nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo stesso nome in cui siamo stati battezzati. Tutte queste frasi non sono un protocollo da seguire, ma l'espressione simbolica dell'evento dell'incontro. Vale la pena preparare la confessione a partire da queste espressive scene evangeliche e meditare sulla formula di assoluzione. In questo contesto, la confessione dei peccati è gioiosa e consolante, perché il penitente sperimenta il perdono delle offese e il bacio sulle ferite. Ne esce confortato, consolato e desideroso di vivere sempre unito al suo Signore.
Figli fragili di un Dio vulnerabile
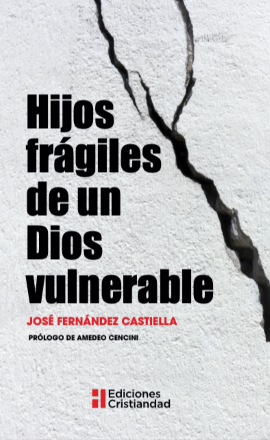
Sacerdote e dottore in teologia morale. Autore di Figli fragili di un Dio vulnerabile (Cristianesimo, 2025).







