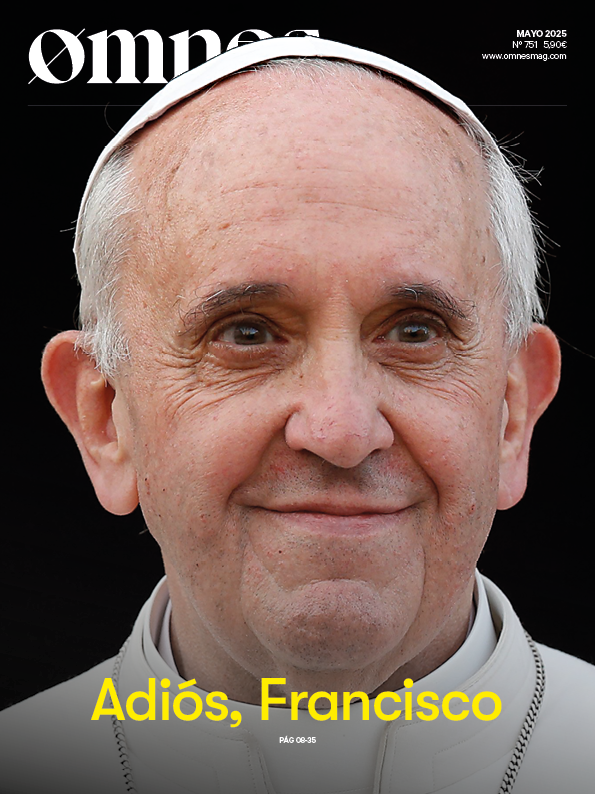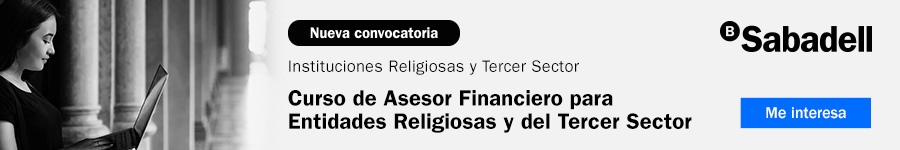A partire dalla fine del XIX secolo, in seguito alla penetrazione del liberalismo in Spagna, si verificò un'enorme frattura tra le classi dirigenti del Paese e la gente semplice. Se tra i primi vi erano casi di agnosticismo o semplicemente di vita non credente, tra i secondi vi era una fede religiosa quasi generalizzata. D'altra parte, esisteva anche una distinzione tra la pratica cristiana nella vita delle periferie delle grandi città e quella dei villaggi.
La scristianizzazione delle masse lavoratrici
La fine del XIX e l'inizio del XX secolo hanno visto la scristianizzazione delle masse lavoratrici in Spagna, soprattutto con la nascita di quartieri estremi e della povertà nelle aree rurali svantaggiate del Paese. Sebbene siano state avviate molte iniziative di carattere sociale, soprattutto a partire dall'Enciclica di Leone XIII, Rerum NovarumIl distacco di grandi masse di lavoratori dal messaggio cristiano è un dato di fatto.
Un fattore chiave per comprendere l'odio scatenato nel periodo costituzionale della Seconda Repubblica spagnola era l'alto livello di analfabetismo presente nella Spagna di allora. Si è parlato della 40% alla fine della dittatura di Primo de Rivera. Solo l'ignoranza spiegherebbe come opere d'arte di valore inestimabile abbiano potuto essere distrutte, templi bruciati senza la minima considerazione. E spiegherebbe anche come la gente del paese abbia potuto credere ad affermazioni così stravaganti come quella che i preti avvelenassero le fontane o uccidessero i bambini con dolci velenosi.
L'ascesa dell'anticlericalismo
D'altra parte, fin dall'inizio del XX secolo, si erano consolidati settori di intellettuali spagnoli formati alla miscredenza, convinti del loro ateismo e agnosticismo, che muovevano abilmente le masse, soprattutto attraverso la stampa. L'azione costante del krausismo e della Institución Libre de Enseñanza ebbe indubbiamente un'influenza.
Una parte della stampa repubblicana insisteva, in quegli anni, nel considerare la Chiesa come un potere spirituale che tiranneggiava le coscienze, ed era quindi urgente liberarsene. A ciò vanno aggiunte le case editrici che sorsero e le edizioni popolari che pubblicarono, così come le opere teatrali, ecc.
L'influenza di alcuni pensatori sarà sempre maggiore e la loro avversione per la Chiesa andrà dalla freddezza all'ostilità. Il suo riflesso più evidente è il crescente anticlericalismo, che divenne una passione tra le masse lavoratrici e in alcune zone rurali. Evidentemente, hanno commesso un errore di calcolo: né la Chiesa era la stessa dell'Ancien Régime, né la fede cattolica era così profondamente radicata come pensavano. Come sottolinea Álvarez Tardío: "Dovremmo quindi rifiutare la spiegazione comune ed elementare secondo cui il laicismo aggressivo dei repubblicani era una risposta all'intollerabile antirepubblicanesimo dei cattolici".
L'obiettivo dell'anticlericalismo non era quello di contestare la dottrina della Chiesa, o i contenuti del Vangelo, o la verità della fede proposta dalla Chiesa, ma di cercare di scrollarsi di dosso il giogo della coscienza e le forme sociali modellate dalla Chiesa. Questi nuovi pensatori volevano una morale laica e principi liberali autonomi.. È interessante notare il fenomeno che si verificò durante il XIX secolo in Spagna: in primo luogo, la comparsa degli intellettuali e, in secondo luogo, il fatto che essi esercitassero un magistero morale, che fino ad allora aveva corrisposto solo alla Chiesa. A causa dell'alto tasso di analfabetismo, non mancarono di parlare alle minoranze. Nel frattempo, il clero, attraverso la catechesi, l'insegnamento e le celebrazioni liturgiche, si rivolgeva alla maggioranza degli spagnoli per tutta la vita.
L'articolo 26 e lo scoppio della "questione religiosa".
Le discussioni intorno all'articolo 26 della Costituzione, nell'ottobre del 1931, fecero emergere una grande quantità di opinioni contrarie all'azione della Chiesa, fortemente cariche di passione. Come sottolinea Jackson: "Non appena si aprirono le cateratte, nessuno fu in grado di riflettere con calma sulla necessità di nuove riflessioni tra Chiesa e Stato". Fu quindi come un fiume in piena di passioni, compreso il nome stesso: "la questione religiosa", che fino a quel momento, per la maggior parte del Paese, era stata qualcosa di accattivante, divenne un problema, e apparentemente uno dei maggiori, perché si prestò più attenzione a questi dibattiti che ai gravi problemi economici, strutturali ed educativi.
Tuttavia, l'influenza della Chiesa cattolica era molto alta in tutto il Paese. Sia attraverso il controllo della maggior parte degli istituti scolastici, sia attraverso i suoi insegnanti, la maggior parte dei quali erano buoni cattolici.
Gran parte degli intellettuali, così come le classi dirigenti, erano cattolici ben istruiti, anche se la loro pratica spirituale era più o meno fervente. Naturalmente, i costumi sociali erano fondamentalmente cristiani. Le buone maniere erano rispettate. Mancavano indubbiamente intellettuali cattolici con la giusta formazione per presentare il messaggio cristiano in modo appassionante, con più forza e coerenza personale.
È interessante notare la situazione generalmente buona del clero durante la Seconda Repubblica. Questo era il risultato dei seminari e delle lauree conseguite in essi, o a Roma presso l'Università Gregoriana. Il clero e i vescovi godevano di salute spirituale: c'era abbondanza di sacerdoti pii, virtuosi, devoti ed esemplari. In effetti, il numero di martiri e confessori durante la guerra civile era impressionante.
Il mito di una Chiesa arretrata
Intellettualmente, vivevano racchiusi in un piccolo mondo intellettuale, ma né i vescovi né il clero erano stati colpiti dalla crisi modernista che aveva scosso l'Europa anni prima. D'altra parte, vale la pena ricordare la situazione delle Facoltà di Teologia spagnole che dal 1851, quando cessarono di appartenere all'Università Civile, erano in declino per prestigio e livello scientifico. Nel 1932, Pio XI pubblicò la "Deus scientiarum Dominus"Era la prima volta che veniva creata una Facoltà di Teologia spagnola. Infatti, nel 1933 la maggior parte di queste Facoltà spagnole furono chiuse e rimase solo quella di Comillas. Nel 1933 ebbe luogo una visita canonica di tutti i seminari della Spagna. Il clero era abbondante, ma mal distribuito.
Né si può dimenticare che la filosofia prevalente di molti studenti universitari era quella della fede nel progresso scientifico, e quindi in una nuova era di progresso senza Dio, o almeno dove Dio era tra parentesi. Ortega y Gasset appare come un modello vicino a molti uomini formatisi intorno alle idee della Institución Libre de Enseñanza. Nel calore di queste idee, si era consolidata la falsa valutazione della Chiesa come nemica del progresso umano.
D'altra parte, in molti villaggi si è conservata una fede consolidata nei secoli, dove la vita ruotava intorno alla pratica sacramentale e alle stagioni liturgiche, riempiendo i costumi, il folclore e le abitudini di vita. C'erano agnostici e miscredenti, ma la maggioranza era cristiana nel cuore.
Cattolici nella Repubblica: tra impegno e delusione
L'avvento della Repubblica, il 14 aprile 1931, e le rapide elezioni della Corte Costituente diedero risultati che lasciavano presagire il peggio per le relazioni tra Chiesa e Stato, poiché la maggioranza dei deputati eletti apparteneva alla sinistra e ai radicali, sopravvissuti alla dittatura di Primo de Rivera.
Il 6 maggio, infatti, la Gaceta de Madrid pubblicò una circolare che dichiarava volontario l'insegnamento della religione nell'istruzione primaria. Questa è la conseguenza dell'abolizione, pochi giorni prima, della confessionalità di Stato. Nel maggio 1931, infatti, vennero bruciate chiese e opere d'arte, come l'Inmaculada di Salcillo a Murcia.
Per questo motivo, quando la maggioranza dei deputati della Camera procedette alla discussione degli articoli della Costituzione, presentò una battaglia frontale contro la Chiesa. La maggior parte di questi deputati non aveva il livello intellettuale e la formazione religiosa necessari, ad eccezione di alcuni intellettuali di riconosciuto prestigio. Alla fine, però, i dibattiti servirono solo a mettere in evidenza la legge dell'aritmetica rispetto a quella della ragione.
Tutto sembra indicare che la sinistra repubblicana abbia presentato la questione religiosa indipendentemente dalla situazione reale del Paese e dall'opinione dei cattolici sulla Repubblica; ciò che li preoccupava era la presenza del cattolicesimo nella vita sociale e culturale.
Un esame delle azioni dei protagonisti: dignitari della Chiesa, membri del governo, parlamentari, stampa dell'epoca, ecc. dimostra chiaramente che quelle Cortes non rappresentavano la realtà del Paese, ma mostravano in tutta la loro crudezza le diverse posizioni contro la Chiesa che esistevano all'epoca in Spagna. Il risultato, come è noto, fu una Magna Carta che non poteva essere uno strumento di concordia e di pacificazione, in quanto nata contro la volontà della maggioranza dei cittadini.
Ancora una volta, in relazione al XIX secolo, una piccola minoranza ha tentato di correggere il corso di un Paese pretendendo, per mezzo delle Costituzioni, di portare avanti un'evoluzione. "Un Paese può essere decatolizzato, ma non in virtù di una legge". In fondo, mancava una vera cultura democratica.
Alcuni deputati repubblicani erano cattolici e avevano avuto un ruolo fondamentale nella nascita della Repubblica, come Niceto Alcalá Zamora, che nel suo famoso discorso contro le disposizioni antiecclesiastiche dell'articolo 26 della Costituzione del 10 ottobre 1931, che lo portò alle dimissioni da Presidente del Governo, disse: "Non ho conflitti di coscienza. La mia anima è figlia della religione e della rivoluzione allo stesso tempo, e la sua pace consiste nel fatto che quando le due correnti si mescolano, le trovo in accordo nell'espressione della stessa fonte, dello stesso criterio, che la ragione eleva a principi ultimi e la fede incarna nell'insegnamento del Vangelo. Ma io, che non ho problemi di coscienza, ho una coscienza (...) E quale rimedio mi resta? La guerra civile, mai (...). Per il bene della patria, per il bene della Repubblica, vi chiedo la formula della pace". Egli avrebbe incarnato quella che chiamava la terza Spagna. Un governo di centro veramente democratico e non confessionale. La sua speranza era che la Repubblica avrebbe contenuto la Rivoluzione sociale e anticlericale.
Vale la pena ricordare il famoso discorso contemporaneo di Manuel Azaña del 13 ottobre 1931: "Ho le stesse ragioni per dire che la Spagna ha cessato di essere cattolica e per dire il contrario della vecchia Spagna. La Spagna era cattolica nel XVI secolo, nonostante ci fossero molti dissidenti molto importanti, alcuni dei quali sono la gloria e lo splendore della letteratura castigliana, e la Spagna ha cessato di essere cattolica, nonostante ci siano oggi molti milioni di spagnoli cattolici e credenti". La traduzione è chiara: lo Stato non è più cattolico. Una volta accettata la premessa, che sarebbe valida: se il popolo spagnolo nel suo insieme decidesse democraticamente che lo Stato deve essere non confessionale. Ciò che non avrebbe senso, invece, è che diventi anticattolico, e che poi lo Stato perseguiti la Chiesa, la privi della sua libertà e cerchi di sottometterla a sé.
Non era la prima volta che un piccolo gruppo, in nome della democrazia, cercava di soggiogare la coscienza della maggioranza. Ma l'accelerazione della storia fa molti danni.
In effetti, la maggior parte delle leggi emanate erano una conseguenza del principio di secolarizzazione dello Stato, ma molte altre erano un attacco alla libertà proclamata per tutti nella Costituzione. Questa mancanza di verità farebbe capire che non si cercava il bene comune, ma piuttosto interessi di parte, finendo per rompere l'armonia e la convivenza pacifica. Naturalmente, "non si è raggiunta una cultura democratica, ma una cultura alternativa".
L'istruzione, epicentro del confronto
L'intenzione della maggioranza parlamentare delle Cortes costituenti era quella di eliminare la Chiesa dall'istruzione, come dimostra l'articolo 16 della Costituzione, ma in pratica non era possibile costruire tante scuole e formare tanti insegnanti quanti ne sarebbero stati necessari.
Infine, vale la pena di ricordare le parole di un altro primo ministro durante la Repubblica, Lerroux, che osservava quanto segue: "La Chiesa non aveva accolto la Repubblica con ostilità. La sua influenza in un Paese tradizionalmente cattolico era evidente. Provocarla alla lotta, appena nato il nuovo regime, era impolitico e ingiusto, e quindi poco saggio.
La reazione dell'episcopato spagnolo
È importante sottolineare che l'atteggiamento della Santa Sede all'arrivo della Seconda Repubblica il 14 aprile 1931 fu cordiale. Lo dimostrano le abbondanti rimostranze del Nunzio e dei prelati spagnoli.
D'altra parte, l'arcivescovo di Toledo, il cardinale Segura, divenne una figura scomoda, a causa del suo approccio tradizionalista secondo cui la Chiesa doveva guidare l'operato dello Stato, e non fece mistero del suo sostegno alla monarchia. La Repubblica riuscì a espellerlo dalla Spagna e la Santa Sede, in un gesto di ingraziamento verso la Repubblica, lo rimosse dalla sede di Toledo il 1.X.1931 e lo sostituì con il cardinale Gomá. Non bisogna però dimenticare che il Governo della Repubblica, il 18.V.1931, promosse l'espulsione del vescovo di Vitoria, Múgica, sollevando il problema del carlismo come forza antirepubblicana e della sua influenza sul popolo basco-navarrese.
Così, con l'adozione della Costituzione in un breve lasso di tempo, nelle fasi iniziali, la reazione della popolazione è stata di tipo "sociale". Vaticano e dei vescovi spagnoli era di serena attesa. La Dichiarazione congiunta dell'episcopato spagnolo del 20 dicembre 1931, in risposta alla Costituzione approvata il 12 dicembre, ricordava che i diritti e le libertà approvati nella Costituzione erano per tutti.
Lo stesso Niceto Alcalá Zamora si dimise da Presidente del Governo per non approvare questi articoli anticattolici, ma presentò la sua candidatura alla Presidenza della Repubblica, al fine - in tempo - di adeguare questi articoli alla situazione oggettiva del Paese. E lì rimase fino all'aprile del 1939.